
Mentre scrivevo di Starfield mi è venuta a mente anche un altro evento vissuto “in diretta” e ciò mi ha fatto riscrivere completamente questa introduzione: l’uscita di un disco dei Tool. Ora, si sapeva che prima o poi 10.000 days avrebbe avuto un seguito ma passati i canonici cinque anni di attesa è scemato tutto nel logorio della vita moderna finendo per poi arrivare a dire “quando uscirà lo ascolterò”. Puntualmente questo disco si è materializzato come un abracadabra, ovvero sono comparse delle nuove tracce in alcune set list di concerti in America, sono sbarcati con l’intero catalogo (tranne Salival) su Spotify e hanno iniziato anche un tour europeo, con un appuntamento al Firenze Rock nel 2019. Il disco uscì alla fine di Agosto del 2019, anticipato di qualche giorno dal primo singolo, Fear Inoculum.
Ed è dall’intervallo che va dal concerto all’uscita del disco che più mi va di ricordare. Almeno per il sottoscritto, gruppi contemporanei di interesse se ne contano pochi, complice anche una sostanziale dipartita di tutto il genere post e qualcosa (Isis, Neurosis, Mastodon) su cui avevo puntato ed iniziato ad ascoltare nella prima decade di questo secolo. Quindi spinto da una nuova ventata di entusiasmo (grazie al sempre presente Spotify) riprendo ad ascoltare nuovamente alcuni loro lavori, ritorno sui forum in cui scrivevo anni fa (quando usavano) e ricordo con affetto i primi ascolti del disco, in cui una sera Mina non riusciva a prendere sonno più del solito. Per non parlare poi del concerto, una performance di un altro livello che la maggior parte delle band vecchie e nuove si sogna, anche in una location a loro poco congeniale. Se il tempo del disco è stato centrato, tutte le altre cose hanno avuto un che di demodè, una prassi del tempo che fu ma è proprio questa eccezione che le ha rese speciali.
Il tutto si concretizza con l’iniziale Fear Inoculum, la prima nuova composizione in 13 anni da parte dei nostri, dove le tablas di Carey e il basso di Chancellor fanno da tappeto alla litania ipnotica di Jones. Sempre il duo Carey – Chanchellor è protagonista nella morbida Pneuma, che ricorda in parte la The Patient di Lateralus ma che rappresenta uno dei picchi sia compositivi che puramente esecutivi del disco. E se nell’imperiosa cavalcata di Invincible viene da aggrapparsi a falsi miti e false speranze, è fissando una foto, con un lockdown ormai imminente, in cui una giovane mamma (venuta a mancare da tempo) è intenta a spingere 2 fratelli su un’altalena, che mi sono venute a mente le parole di Descending: To be or not to be / Rise / Stay the grand finale / Stay the reading of our swan song and epilogue.
Una sostanziale chiamata alle armi di fronte a ciò che si sgretola, che sia una famiglia o la vita come la conosciamo, poco importa. Ma spesso non è “che cosa può succedere” a spaventarci bensì che una tale possibilità possa solamente esistere. Una paura che paralizza ma che deve essere guardata (Fear Inoculum), che possiamo lasciarci alle spalle in quanto rappresentiamo un “oltre” (Pneuma), l’inevitabile a cui fare un’alzata di spalle (7empest). Aspetti ripresi nell’ottimo pezzo strumentale, Litanie contre la peur, che prende spunto dalla Litania Bene Gesserit (dal libro di Frank Herbert, Dune): non dobbiamo aver paura, la paura uccide la mente.
In un ora e mezza i Tool cercano, nell’ennesimo bagno di fuoco, con il loro fare tentacolare (e a questo giro spesso piuttosto derivativo) tra percussioni e ritmiche intricate, slanci psichedelici, atmosfere catartiche e rasoiate heavy metal, di mettere ordine al caos. Un caos ragionato, non nel mondo ma dentro noi stessi.
Questa è, a scanso di equivoci, l’angolazione da cui lo osservo, il suo tratto distintivo, ciò che rimane di un setaccio meticoloso, fatto di aspettative (ma non di puro hype) e numerosi ascolti. Come se lo osservassi dalla sua costina, invece che dalla prima di copertina.
Perché di angolazioni (o premesse per i più puntigliosi), ve ne sarebbero diverse, collezionate in un arco di ben 13 anni, periodo in cui scrissi “aspetto il disco nuovo, il tour e poi metto su famiglia” per poi fare esattamente il contrario, dove ciò non ha rappresentato necessariamente un male, anzi. Ma in musica sono di fatto un’era geologica. Un’attesa lunga che si accorcia inaspettatamente ad un paio di mesi. Una decelerazione improvvisa, un viaggio interstellare di anni luce in una capsula medica, dove si viene di colpo svegliati per poi ritrovarsi a sorseggiare del caffè con il resto dell’equipaggio. Ma nella realtà il tempo non si può colmare così facilmente e più esso è lungo e più la distanza con chi è dall’altra parte aumenta. E passati i canonici cinque anni da 10.000 days, anche i fedelissimi hanno iniziato a non farsi più domande su quando sarebbe uscito qualcosa a firma Tool. Chi a vent’anni ascoltava Aenima o rimase folgorato sulla via del Lateralus, oggi ha cambiato mestiere facendose una ragione, perché da persone che hanno passato i sessant’anni anni si accettano solo prime volte o rimpatriate, come uno zio che ti da di gomito alla vista di una bionda. E chissà in quale momento della storia ci siamo giocati il ricambio generazionale perché ventenni disposti ad ascoltare certe cose non ve ne sono. Con un livello di attenzione equivalente ad una storia su Instagram, un disco di più di 70 minuti equivarrebbe ad una tortura da far impallidire quella di Ludovico Van. Vero che l’assenza crea attesa, l’attesa crea aspettativa ma l’aspettativa crea delusione, in un elastico pressoché infinito.
Come se non bastasse, ad ampliare la distanza, anche alcune scelte commerciali della band non sono state proprio le più indovinate, tra cofanetti “sti gran cazzi edition” con schermi LCD venduti a cifre esorbitanti, dischi senza le tre tracce strumentali a causa del mancato spazio fisico e un logo ed una copertina oggettivamente inguardabili. Inoltre, nei momenti più caotici, ho avuto la sensazione che la batteria e il basso siano stati compressi con la chitarra di Jones a volumi troppo alti.
Sarebbe inglorioso oltre che ingiusto fare un confronto con gli album precedenti, quelli (Undertow, Aenima, Lateralus) avevano una fiamma dentro che per forza di cosa la vita ti porta a spengere e un suono più orizzontale lo avevano già adottato con 10000 days e per certi aspetti può anche essere giustificato. Alcuni riff e anche il modo di cantare di Maynard ci sono anche nei primi 2 minuti di Lateralus, ma là c’era un piano chiaro, un “ride the spiral to the end”, erano lunghe composizioni dove bisognava solo lasciarsi trasportare. Qua invece ho l’impressione che alcune parti di canzoni siano state unite con la forza, con Keenan che spesso scompare lasciando andare gli altri 3 a briglia sciolta, perdendo di fatto la bussola. Come il tizio che parla di un argomento, poi per caso prende una tangente per l’ignoto salvo poi cercare di riprendere il filo discorso con un generico “cosa stavo dicendo?”. A volte viene bene (7emptes) altre male (Fear Inoculum, Pneuma, Descending). Credo che questo sia il difetto principale del disco e sia anche stata la loro principale difficoltà, quella di “chiudere le canzoni”. Di motivi ne ho letti tanti, dalle lunghe jam senza Maynard, a dischi finiti e buttatti anni fa (sempre per il discorso di non essere all’altezza), a scazzi vari personali. E scrivo così’ (da notare anche il decadimento del mio linguaggio) perché ancora sto rosicando sulla sopra citata Descending. I primi 7 minuti sono, tra testo e sezione ritmica, quello che i Tool sanno fare meglio, poi Maynard scompare e arriva Adam che spara 3/4 riff per 8 minuti! Ne bastava uno che tenesse alta la tensione o che alleggerisse il testo. Ed il twist su Invincible, così muscolare e ben ritmato, funziona ma perché rallentare a quella maniera il ritmo usando anche quel terribile vocoder? La stessa cosa c’è (anche se in parte minore) nella title track mentre in 7empest, i riff di Jones ci possono stare perchè è la parte vocale che ne è al servizio e non viceversa. Spesso Jones, Carey e Chancellor sembrano fidanzatini al telefono, “dai smetti di suonare tu, no tu, dai prima tu”. E si va avanti così per minuti. Inoltre vi sono dei suoni e delle soluzioni già sentite e risentite, con autocitazioni vicino alla denuncia per plagio. Non faccio l’elenco ma ce ne sono a iosa e il dire “serve per ricollegarsi a…” non vale altrimenti ci tocca rivalutare tante discografie da vergognarsi. La necessità di fare una canzone come Culling Voices lo capirò quando sarò grande o forse morirò prima di capirlo.
Nonostante sia lungo 1 ora e 26 minuti con i difetti sopra citati, l’album scorre bene perché le canzoni sono sì lunghe ma in definitiva sono solo sei, offrendo spazi di musica di un certo livello a cui eravamo ben abituati. E’ un album che si basa principalmente su dei momenti: la prima parte di Fear Inoculum, il climax di Pneuma con quel mood tribale, la cavalcata finale di Invincible (dove arriva Maynard a salvare la baracca in una canzone andata ormai alla deriva), la già citata Descending e anche la conclusiva 7empest. A loro modo, i Tool non si sono risparmiati e hanno provato ad affacciarsi in un mondo diverso in cui avevano inciso gli ultimi dischi dando comunque un importante contributo alla musica degli anni ’10.
Riassumendo: “Fear Inoculum è un tema scolastico lungo e prolisso, scritto in bella grafia e con qualche frase qui e là molto ispirata, una serie tv con uno sviluppo narrativo troppo lungo e ripetitivo, ma con delle mezze puntate ben girate e con scenografia molto bella. E’ una scatola di Lego con tanti mattoncini bellissimi e di materiale pregiatissimo, ma dai quali non si riesce a tirar fuori modelli particolarmente fighi.” (cit.)
Tool – Fear Inoculum (Volcano Records, 2019)
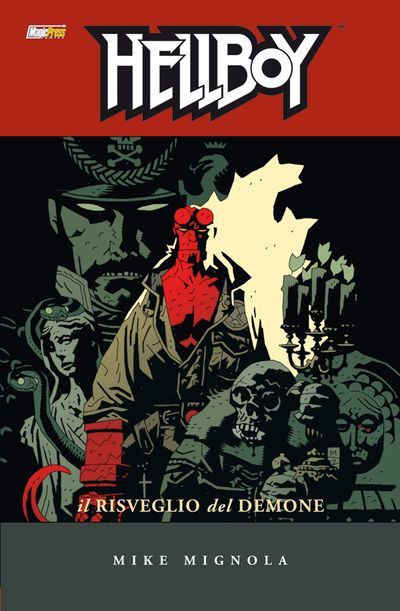



Lascia un commento