Originariamente scritto per Rock e d’Intorni, un forum di simpatici ragazzi in cui scrivevo tanti anni fa grazie ai riuscì a mettere ordine in un ascolto “matto e disperatissimo”.
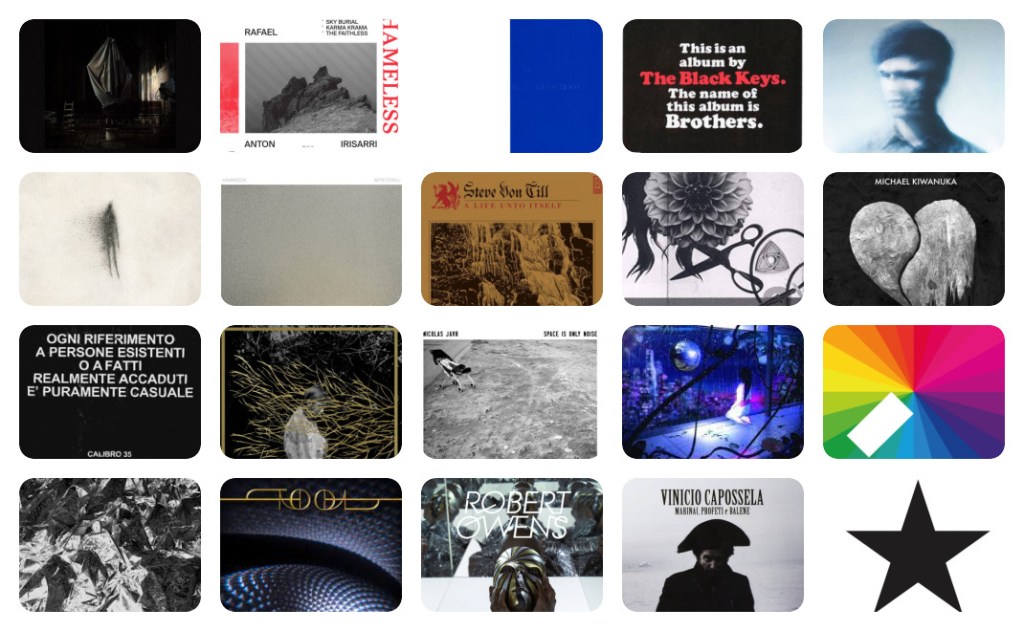
Mannaggia a voi che mi trascinate in queste cose! In questi anni avevo già scritto un po’ di cose, quindi mi son detto, ma sì vai è facile, vai di copia/incolla e via! In realtà alla fine ho ripercorso le cose che avevo ascoltato in questi 10 (davvero tanta e tanta l’ho lasciata fuori) e in fondo è stata la cosa che più mi ha fatto compagnia. In fondo sono dieci anni di vita!
Se la decade prima era stata quella del “ascolto tutto” questa è stata sicuramente quella della maturità. Ho trovato i miei generi, sono stato al passo con le uscite, ho legato dischi a dei momenti particolari ed ho comprato tanti dischi. Insomma, è stato un bel tuffo nel passato.
Mi son dato alcune regole. All’inizio erano più stringenti, poi mi sono accorto che un punto di classifica in più o meno non avrebbe inficiato il valore del disco (e potevo starci sopra 3 mesi), quindi considerate che i primi 3 sono, per me, dei masterpiece. Un album per artista. Spesso è il suo esordio, a volte quello più rappresentativo per diversi motivi nella sua discografia, a volte è quello a cui sono più affezionato.
Chiudo dicendo che, rileggendo i nomi qua sotto, si sia arrivati alla fine di un capitolo. Chi non c’è più, chi si è bruciato con l’esordio, chi ormai ha già prodotto tre o quattro album di livello e il suo l’ha detto, chi si è dovuto reinventare. Chissà cosa ci riserverà questa decade appena iniziata, sperando di poterla vivere e raccontare con gli stessi sentimenti di questa appena trascorsa.
Ammetto candidamente di non essere non solo un fan di Bowie, sono solo un ascoltatore “per completismo”, non ho mai finito un disco per intero, canzoni come Heroes mi scoglionano dopo 2 note, Ashes To Ashes e Let’s Dance hanno quelle sonorità di plastica tipiche degli anni ‘80 che mi fanno effetto kriptonite, non so niente delle avventure di Ziggy Stardust, Starman me la ricordo perché era la canzone master del programma Meteore. Come tutti quelli della mia generazione, mi ricordo di Bowie in Labyrinth.
Bowie è comunque un gigante della musica, forse “il personaggio” musicale per eccellenza, passato attraverso molte epoche musicali grazie anche a tanti travestimenti, pseudonimi, soprannomi e ambiguità.
E a me questo disco tutto sommato mi piace. Ha dei picchi emotivi notevoli, Lazarus e la title track sono perle di rara bellezza compositiva. Non lucra su niente, lascia piuttosto un senso di “punto e a capo”, di ultimo giro di valzer. E’ un disco sincero, supportato anche da una band in palla, di chi ormai non ha assolutamente niente da perdere ma vuole, fino in fondo, poter lasciare e alla sua maniera, il proprio contributo. Ed è sincero il mio apprezzamento.
- Vinicio Capossela – Marinai, Profeti e Balene (2011)
Immenso viaggio tra il fondale marino, inferi della terra, luoghi nascosti e chi più ne ha più ne metta. Il mare come metafora della vita, la vita come lotta perenne con nemici invincibili – la balena, Polifemo, Dio. Ma anche amore, resurrezione, rinascita e rivincita.
Opera titanica e spropositata, piena zeppa di citazioni letterarie e non – Moby Dick, il libro di Giobbe, l’Odissea, Dante Alighieri, Céline – certo non facile, ma va presa così, tutta d’un fiato.
- Robert Owens – Art (2010)
Sulle scene ormai da una vita, Robert Owens viene sistematicamente chiamato “Il Maestro”. E solo un maestro poteva fondere così meravigliosamente il soul e la house, dando a un sound con chiari riferimenti al passato una veste così nuova.
In quasi due ore di musica si può trovare la sensualità di Marvin Gaye, il blues, il jazz, il funky, il dubstep, l’hip hop. Una nota di merito va a Larry Heard e Atjazz, venuti a portare eleganza e luce, nonché alla straordinaria voce di Owens, protagonista assoluta in Ancestral History e in One Love.
Anni fa nel forum scrissi: aspetto il nuovo disco, un tour e metto su famiglia. E’ andata esattamente nel senso, ma non fa niente. Probabilmente il disco negli anni non rimarrà, ha dei picchi assoluti inavvicinabili per tanti (i primi 6 minuti di Descending), alcune cose buone, altre sono vicine allo skip.
Ma è stata l’attesa del disco che più mi va di ricordare. L’uscita del singolo, il ritornare su alcuni forum a leggere qualcosa, i primi ascolti quando la bimba dormiva. Per non parlare poi del concerto, mi sono sentito in pace. Tutte cose fuori tempo massimo e anacronistiche, ma è forse questa eccezione che le ha rese speciali.
E’ passato un po’ di tempo ma credo che questo disco dei Barn Owl (duo formato dai californiani Jon Porras e Evan Caminiti) sia stato una dei primi dischi che ho ascoltato di questo genere (che nuovo ovviamente non è) e che quindi merita di essere ricordato. Forti dei loro lavori solisti precedenti a questo disco, i nostri uniscono le forze e realizzano una full immersion oscura, dilata, che passa tra il doom e l’interstellare (Voix Redux), tra distorsioni in un’atmosfera impalpabile (The Long Shadow Against the Night), affreschi schulziani (Blood Echo), fino a lidi ancestrali (Pacific Isolation) e alla meravigliosa The Opluent Decline, la lunga suite che rappresenta l’attracco definitivo.
Fermo con il progetto principale e dopo aver remixato di tutto, da Adele ai Radiohead, In Colour segna il debutto da solista della fondatore nonché mente pulsante degli XX, Jamie Smith.
L’album raccoglie tracce lanciati a pezzi e bocconi e rappresenta un piccolo bignami delle capacità di Jamie XX, un compendio di post dubstep soul, house, uk garage, folktronica a piene mani, una psichedelia da camera e un amore per la black music.
Impossibile non sentire all’inizio di Gosh e Hold Tonight la ruvidità di un Burial o un Kode9, l’allegria spensierata di Four Tet in Sleep Sound e SeeSaw, la travolgente coralità di Loud Places. Chiude la meravigliosa In Girl, anima soul-disco su un meraviglioso giro di basso.
Rain Temple è il seguito di Atarashii hi no tanjou uscito nel 2015 a firma 2814. Anche stavolta la copertina è fonte di ispirazione: se in Atarashii hi no tanjou l’osservatore principale era lo stesso che guardava la copertina, stavolta si fa un passo indietro perché si osserva una ragazza in bianco intenta a contemplare un paesaggio simile a quello del disco precedente. Una prospettiva diversa, così come sono diverse le dinamiche all’interno del disco rispetto al lavoro precedente.
La maestosa Before The Rain – degna dei miglior Saad – spiana la strada al loop in crescendo di Eyes Of The Temple, mentre l’ipnotica Lost In A Dream potrebbe stare benissimo dentro a un disco di Andy Stott. Guided By Love ricorda il post rock dei primi Sigur Ros mentre Transference unisce trip-hop e shoegaze in un tubo al neon. La vaporwave torna a fare capolino in questa bella prova di conferma nel trio conclusivo This Body, Contact e Inside The Sphere.
Debutto vincente su lunga distanza per Matthew Barnes con il moniker Forest Sword, dopo una serie di validi ep.
Di fatto un calderone di ritmi trip hop, post rock, voce a bassa fedeltà, cut and paste, echi soul e folk, una spruzzatina dream pop. I clangori metallici di Thor’s Stone ricordano i Demdike Stare così come Onward e The Plumes, mentre tribalismi e ritmi orientali la fanno da padrone in Irby Tremor.
La soul step di An Hour va a braccetto con Anneka’s Battle, pezzo in stile Bath For Lashes mentre Gathering è un portentoso call and response. La monumentale The Weight Of Gold e la chiusura con Friend, You Will Never Learn, racchiudono tutto quanto detto finora: ritmo sincopato, anima celestiale, voce low-fi e groove impressionante.
Altro esordio con il super botto. Nicolas sembra un sarto di lungo corso; taglia, cuce e ricama. Rivoli d’acqua, field recording di vita quotidiana, pianoforte, campionamenti illustri (Ray Charles nella sua I Got A Woman, miglior canzone del disco), archi, groove tra il trip hop e la house. Da qui in poi Jaar diventerà una star internazionale, acclamato in tutti festival internazionali e djset, rilasciando anche due dischi a nome A.A.L. dove si strizza l’occhio al dancefloor e compagnia bella.
Che i Calibro35 siano una delle migliori band italiane su piazza non credo che sia un mistero. In 10 anni hanno prodotto 6 dischi, cambiando molto spesso forma e contenuto, pur mantenendo sempre quel groove che da sempre li contraddistingue. Ho scelto questo disco perché (l’ultimo secondo me è anche meglio, perché pur non avendo un’idea di fondo le canzoni “puff” hanno tutte clamorosamente un senso e suonano a meraviglia) semplicemente è con questo che li ho conosciuti.
Questo è il terzo album per la formazione milanese, uscito per la Venus, che segna uno smarcamento dai dischi precedenti con pezzi più compatti e l’aggiunta delle voci (in ben tre canzoni). Proprio questo è l’elemento che più caratterizza questo album: con Uh Ah Brrr è già l’ora dell’aperitivo, un bel Cynar con Il Pacco e poi tutti a fare una bel furto con scasso in La Banda Del B.B.Q. (Brooklyn, Bronx, Queens), misto funky e i Proppelerheads dei tempi d’oro. L’album si apre con il basso misterioso di Luca Cavina e la canzone è tutta un nascondersi nella notte fino all’inseguimento finale, si va poi a New Dehli Deli tra i Beatles e i Kula Shaker, per scivolare in un po’ di romanticismo in Buone Notizie.
Ma la giornata prima o poi finisce, il Massacro All’Alba non è un’opzione ma un destino, il pezzo migliore del disco, epico, cattivo, tutto groove di basso e tastiere. Immancabili le due cover New York New York di Piero Piccioni e Passaggi Nel Tempo di Ennio Morricone.
Michael Kiwanuka è un ugandese emigrato a Londra. Impara a suonare la chitarra ma, per sua stessa ammissione, non aveva mai pensato di poter diventare o il leader di una band oppure di produrre dischi a nome proprio. Fa semplicemente il turnista. Dopo il buon esordio con Home Again, Michael stavolta ci crede fino in fondo e piazza nella magnifica opener Cold Little Heart i Pink Floyd più scintillanti e la sua morbida voce.
Ed è questa maturità artistica a spiccare appena premuto play, soprattutto nel trittico a metà disco in Falling, Place I Belong e la title track (che nel mood ricorda Inner City Blues di “che te lo dico” a fare Marvin Gaye).
Love & Hate è un viaggio sincero, un disco di ampio respiro, più impegnato del precedente. Di fatto uno dei migliori dischi di musica black-soul del decennio, per un personaggio che ancora rimane con la barra diritta (a riprova, anche il recente KIWANUKA è molto valido).
- Demdike Stare – Elemental (2012)
Scoperti per puro caso, il duo formato da Sean Canty e Miles Whittaker, mi affascinò da subito, con i dischi precedenti Symbiosis e Tryptych. Elemental riprende i tre Ep precedenti (Chrysanthe & Violetta, Rose e Iris) con alcune canzoni in alternate version. Ed è di fatto l’epica conclusione di un percorso nato con Symbios per il duo inglese, dove dub muscolare, post industrial, ectoplasmi techno, drone, tessiture ambientali da horror-soundtrack ed esoterismo si mescolano in un suond post-nucleare. Li ho visti anche dal vivo, da solo, nella mia città e furono 2 ore e mezza spettacolari.
Il maestro dell’Idaho (voce e mente dei Neurosis) giunge al quarto disco solista, da aggiungere al non meno importate progetto Harvestman. Niente sfuriate post metal della band madre, ma un folk oscuro, voce baritonale a scandire inquietudini giornaliere sopra un pianoforte dismesso e un fingerpicking magistrale.
Album minimale ma di una ricchezza timbrica meravigliosa, merito anche della viola affidata a Eyvind Kang, con Pat Schowe alle percussioni e J. Kardong alla pedal steel. Elegante come un funerale, un disco meraviglioso.
“Quando succede qualcosa di simile, a volte il silenzio è la risposta migliore, perché non sai cosa dire quando qualcuno sta vivendo quel dolore. C’è il tempo in cui puoi giocare nell’oscurità e puoi glorificarla e romanticizzarla. E poi c’è il tempo in cui essa è presente ed è reale.”
Mysterium era inizialmente nato con tutt’altro intento ma la scomparsa nel 2016 di Clark Kern, figlio della sorella di Byrd, ha cambiato il lavoro in corsa (basta semplicemente leggere i titoli delle canzoni).
L’intento è quello di mantener fede alla promessa iniziale, affidandosi a commoventi archi nella monumentale opening Now And Over Yet, aggrappandosi ad un coro di voci (Mysterium, I Would Give My Breath Away, Dust Swirling Into Your Shape), a poche note di piano e chitarra immerse in un elettronica dilatatissima (When The Body Breaks, Nominus, Thing Of Beauty Burn). Oscurità e luce si trovano Dust Swirling Into Your Shape e l’album si snoda in un crescendo continuo, frutto di un’eccellente compattezza compositiva che trova il suo definitivo climax in Remeber Our Bewildered Son ed Elegy. Gli Hammock ci trasportano mano per la mano nel loro lungo viaggio ed è nel finale colorato alla Sigur Ros di This Is Not Enough in cui si abbozza un sorriso per reagire alla sofferenza.
Supportato magistralmente da Francesco Donadello, Peter Katis, l’orchestratore di Amburgo Roman Vinuesa e in particolare tutto il Budapest Art Choir, il duo americano americano realizza un requiem non scontatamente funebre ma che crea una profonda empatia con chi lo ascolta, dosando saggiamente parti orchestrali, inserti ambient e cori, mai come in questo album determinati. Equilibrando saggiamente questi tre elementi riescono a creare un continuum narrativo, realizzando di fatto un’elegia profondamente sincera e sentita.
Seguo Matthew Cooper ormai da un po’ di tempo, credo da dopo l’uscita di Copia (2007) dopo averlo visto, per caso, dal vivo di spalla agli Explosion In The Sky. Presenza sempre discreta la sua, non un mostro di prolificità visto che gli ultimi due dischi sono equamente divisi nell’arco di 6 anni (Smiles nel 2010 e Nightmare Ending nel 2013).
A questo giro Eluvium riprende in mano la sua creatura e piazza un deciso colpo all’evoluzione del suo sound: sé Copia era il capolavoro dell’equilibrio da ambient e musica orchestrale, qua il matrimonio è tra ambient e canto sacro. Le struggenti voci liriche (Strangeworks, Regenerative Being, Movie Night Revisited, Rorschach Pavan) condotte da scie di chitarre e sintetizzatori in una forma orchestrale dai contorni estremamente sfumati, sono carezze della mano più amorevoli, la perfezione cristallizzata tra i ghiacci di Erebus – precedente collaborazione di Eluvium con Bvdub.
E anche gli interludi (Fugue State, False Readings On) o i semplici pezzi più ambient cementano ancora il leitmotiv del disco, la suddivisione di un istante, così come l’uomo in copertina, un insieme di puntini trascinati da una marea sonora.
- James Blake – James Blake (2011)
L’esordio degli esordi. James Blake è un ragazzetto classe 1989, nato a Londra, figlio di James Litherland – storico chitarrista dei Collosseum. Ha un ciuffo che gli cade sulla fronte, è timido e ascolta Burial. Nel 2010 si fa notare per tre Ep dal titolo The Bells Sketch, CMYK, Klavierwerke. Ma è con il primo album vero e proprio che James Blake riesce a fare il pieno di ascolti e successo tra gli addetti ai lavori e non.
Ha avuto l’intuizione giusta James Blake. L’intuizione giusta che lo differenzia da altre nuove leve – James Woon, The Weeknd – è quella di aver aver rimesso al centro della propria musica la voce, senza ricorrere al canto di altri o di sampler sparati in loop. E nonostante gli effetti su di essa, ha molto calore e riesce a toccare le corde giuste.
Le basi sono delle piccole spruzzate di dub, di glitch, di wonky qua e là per raccogliere e fare da tappeto alla voce. Un disco di straordinaria intensità che dà il meglio di sé nella seconda parte, con la meravigliosa cover di Feist, Limit To Your Love e la morbidezza di I Mind e To Care (Like You).
Farà meglio anche nel disco successivo, produrrà singoli, ep ed altri due dischi. Ma è troppo timido per diventare famoso ed andrà un po’ in confusione.
Dopo quasi 10 anni di carriera, i Black Keys con questo album cambiano definitivamente il loro sound, riuscendo a compiere una metamorfosi che era rimasta in sospeso con l’album Magic Potion. Il duo mette da parte i riff tagliati con l’accetta di Thickfreakness e Rubber Factory per far posto ad una miscela funky (Everlasting Light, Next Girl) e soul (Too Afraid To Love You, Ten Cent Pistol) sicuramente più ascoltabile (e digeribile) ai più ma non per questo di qualità inferiore. Ma non solo. Gingilli prettamente pop come Tighten Up, The Only One e Never Gonna Give You Up nei dischi precedenti non c’erano mai stati. Ritorna il blues, con quel refrain alla She’s Alright di Muddy Waters, nella trascinante She’s Long Gone, mentre Black Mud è il solo pezzo strumentale.
E’ il disco che lancerà i Black Keys nell’iperspazio del successo. Da qui in poi non sarà niente più come prima (purtroppo).
Per mia moglie, il perché mi piaccia la musica che fa questo tizio e il perché lo ascolti da anni, rimane un grosso mistero. Ho provato a farglielo vedere dal vivo ma la prima volta si è addormentata mentre alla seconda, addirittura al ClubToClub nel 2017 (incinta) è uscita dalla sala. Se provo a spiegarglielo a voce, alla terza frase mi dici “si ma vieni al sodo”. Quindi è ufficiale, c’ho rinunciato.
Di Ben Frost mi ha sempre affascinato il risultato di essere “un gesso su una lavagna”, avete presente no? Ma By The Throat è del 2009. Sono passati un po’ di anni, nel frattempo ho ascoltato anche altre cose. Ed anche Frost non è stato fermo, diventando – già con il precedente Aurora, disco che non ho mai apprezzato fino in fondo – un “terrorista sonoro”. Al ClubToClub ho visto diversa gente tapparsi le orecchie fin dalle prime note di Threshold Of Faith. Erano le solite persone che 10 minuti prima erano nell’altra sala a vedere Arca & Jesse Kanda, quindi credo che a certi volumi fossero abituati, o perlomeno sapevano a cosa andavano incontro.
Il problema di fondo è il dove vuol andare a parare l’irrequieto Frost. A fronte di questa muscolarità sonora, fatta di scelte da ciglio ancelottiano (tra cui Steve Albini come produttore), alcuni titoli delle canzoni buttati lì a casaccio, una debordanza in tutto e per tutto, si rimane spaesati e tanto valeva tenersi l’Ep Threshold Of Faith.
Se invece ciò è virtù e non vizio, dove tutto alla fine si disperde e si inizia con il bianco finendo con il blue, districandosi tra respiratori artificiali (Threshold Of Faith), le rasoiate techno di Trauma Theory, momenti tra Apex Twin e Tim Hecker (A Single Hellfire Missile Cost $100,000, Healthcare), scenari alla Blade Runner (Eurydice’s e Meg Ryan Eyez), tra le storture marziali di Ionita o i beep intergalattici di All That You Love Will Be Eviscerated, beh allora Ben il centro non lo tiene – Things fall apart, the centre cannot hold è un verso tratto dalla poesia The Second Coming di W.B. Yeats – ma l’ha preso in pieno.
L’introduzione a questo disco l’ho scritta 4 o 5 volte, non trovando mai la versione che più mi convincesse. Credevo fosse il blocco dello scrittore quando invece, alla fine, ho capito che non c’è molto da introdurre, verificando ancor di più il detto “che parlare di musica è come ballare di architettura”. Allora mi calo in un mare di sincerità e mi limito a raccontarvi ciò che so e che ho ascoltato. Rafael Anton Irisarri, compositore americano tornato a produrre a proprio nome dopo un paio di anni spesi in collaborazioni e progetti paralleli.
Fin dalla copertina, in parte atipica, sfondo bianco con impresse in rosso il titolo dell’album e in nero le tracce, una roccia immersa in una marea grigia, mi aspettavo una noia mortale. Invece mi sono trovato davanti un sound monolitico ma che non affonda l’ascoltatore nell’oppressione, anzi lo rapisce grazie al lento fluire delle sue molteplici sfumature.
La malinconia di Indefinite Fields, avvolta in suono sgranato, confuso, che ti avvolge e ti lascia lì sospeso. Il crescendo di droni fino alla monumentale estasi finale di RH Negative o quello spigoloso Sky Burial. La struggente armonia di Bastion. La disarmante decadenza di Karma Krama e l’onda di The Faithless che, così come piano piano è arrivata, se ne torna indietro senza lasciar traccia di essa.
Se questo è il tempo di chi è senza vergogna, il compositore americano registra il disco per un’etichetta messicana, la Umor Rex e collabora nelle ultime due tracce con un Siavash Amini, un producer iraniano.
In cima a tutto non poteva che esserci lui, per me. La scelta era ampia ma non facile. In una decade il canadese ha prodotto dischi straordinari come Ravedeath 1972, Virgins, Love Streams, Konoyo (ci metto anche Dropped Piano) diventando un big della musica elettro strumentale contemporanea.
Ho scelto Virgins. Se An Imaginary Country puntava su una tavolozza infinita per dipingere il proprio paese ideale e l’organo in The Ravedeath per andare oltre, qua si gioca tutto sulla conflittualità tra il pianoforte e un magma dronico, aspettando un segno per diradare le nuvole, vedi ad esempio Virginial I & II e le due Live Room. Se Stigmata I riprende la magniloquenza di The Ravedeath, è Stigmate II – pur ricordando la Killshot in apertura di Ben Frost – a sciogliersi in dolcezza nel finale. Chiude il disco la potentissima Stab Variation. (così avete capito anche l’origine di questo spazio).
Non avevo mai trovato, in ormai 15 anni che ascolto musica con orecchio e passione, un disco che rappresentasse in maniera così chiara ed evocativa uno stato d’animo. Il suo incedere wagneriano, quel pianoforte sgraziato, il perfetto incrocio tra massimalismo e minimalismo, gli archi carichi di malinconia sempre in lotta con quei droni pesanti come macigni, quei piccoli bagliori di luce sono state la colonna sonora dell’’annus horribilis che è stato il 2015.
L’ho scelto perchè è stata la soundtrack di un preciso stato emotivo, la colonna sonora per tempi incerti e dolorosi.
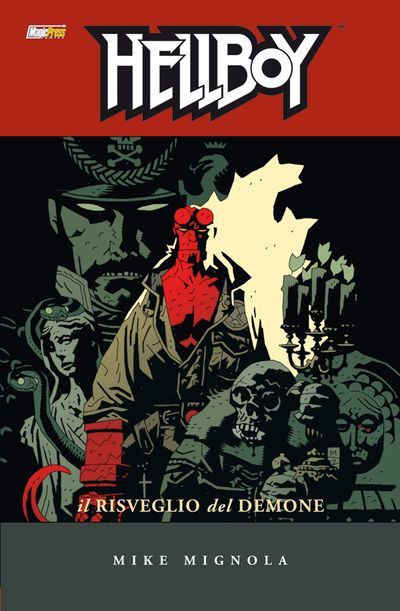



Lascia un commento