Complice la settimana bianca e qualche “rincorsa lavorativa”, sono un po’ in ritardo per il classico ricapitolando del mese di Marzo. Ed ho pure fatto un po’ di confusione con il calendario e la programmazione ma tant’è, andiamo avanti.

Mese monopolizzato in buona parte dai Judas Priest, sia per via del nuovo disco Invincibile Shield (2024), uscito esattamente cinquant’anni dopo il disco di esordio (Rocka Rolla, 1974) che per il concerto che si è tenuto il 7 Aprile al Forum di Assago, del quale parlerò nel riassunto di Aprile.
Dopo il validissimo Firepower del 2018, anche in questo Invincibile Shield i nostri non si risparmiano in niente, nel tiro indiavolato, nel groove, nei volumi e nella durata. Trovata la quadra nella line-up, con il Metal God in formissima insieme alla collaudata coppia Hill – Travis, risultano fondamentali gli innesti dei due “giovanotti” Richie Faulkner, già nei Priest dal 2011 in sostituzione di K.K. Downing uscito dalla band per varie divergenze, Andy Sneap, il produttore di Firepower e sostituto di Glen Tipton nei live in quanto affetto dal morbo di Parkinson. Seppur accreditato, a causa della malattia, Tipton riveste sempre più un ruolo marginale della band ed anche in studio diverse parti sono state composte e suonate dallo stesso Sneap.
Come detto, l’album si presenta con un bel bagno di fuoco a firma Judas Priest, con il trio schiacciasassi Panic Attack / The Serpent and the King / Invincible Shield lanciato a tutta manetta.
L’album si snoda sulla pachidermica Devil in Disguise (che nella parte centrale fa il verso a Metal Gods) alle sfuriate quasi trash di As God Is My Witness mentre Crown of Horns, è stato il primo singolo che ho ascoltato ed ero rimasto un po’ a mezza via, perché mi sembrava il classico pezzo pop rock innocuo con tanto di assolo telefonatissimo. La penso sempre così, ma dal vivo la canzone è diventata un’altra cosa per motivi che vi dirò più avanti. Ma su disco è così e tale rimane. Escape for reality (ed in parte Sons of Thunder), seppur non malaccio, pagano qualche effetto alla voce vicino un po’ a qualche produzione Ozziana&Sabbathiana degli ultimi tempi.
La parte finale è quella che preferisco (che nella Deluxe è quella centrale visto che sono presenti altre 3 canzoni), con Trial By Fire e Giant In The Sky a farle da padrone. In sostanza un buon disco heavy metal che ci presenta la seconda (ma anche la terza o la quarta…) vita di una band storica in buona forma. Non era scontato.
Ma proprio i Judas Priest mi offrono un assist per parlare della spinosa questione “nuovi lavori” di artisti (o gruppi) in età da bocciofila o direttamente “ai Cipressini”.
Il mondo della musica non è nuovo a reunion, come back, rimpatriate senza Tizio o Caio, super gruppi per fare arrabbiare Sempronio, quindi non mi dilungherò inutilmente, tanto il fenomeno è super conosciuto. Dico solo che un tempo, visto gli scarsi mezzi economici, i gruppi incidevano un disco in un paio di giorni (magari super sbronzi o strafatti proprio per l’occasione), dove spesso proprio la fretta creava una “buona la prima” tale da rimanere poi nella storia. Ora non è più così perché tutti i grandi gruppi hanno studi di proprietà. Ogni membro incide le sue parti, grazie e arrivederci. In più, per accattivare da una parte l’ascoltate medio, dall’altra il collezionista sfegatato, di ogni album esistono diverse versione con diverse tracklist a seconda del “package”, risultando di lavori pachidermici pieni di filler. Ma perché quando avevi da dire qualcosa il disco durava 40 minuti, ora che non hai più nulla dire dura più di 50?
Lo scorso anno abbiamo avuto i Metallica con il loro 72 Season (2023) ed i Rolling Stones con Hackney Diamonds (2023), il primo disco dopo la scomparsa di Charlie Watts.

I Four Horsemen hanno fatto quello che fanno da Load in poi, ovvero, sistemata la batteria di Lars in modi più o meno leciti, si dilettano a fare canzoni, indovinando ogni tanto un assolo, qualche linea vocale, lasciando il basso e la fantasia a casa. I classici dischi che vivono “di momenti” dove il sottoscritto magari una volta in palestra una 72 Season o una Screaming Suicide se la spara. Il fatto è che l’intro dura quasi 2 minuti, con la voglia degli ultimi tempi potrei aver già smesso di allenarmi prima che la canzone inizi sul serio e con questo tipo di prodotti fanno ancora di più incazzare tutta quella parte di fan storici che non li sopporta più dalla crociata di Napster e Tom Cruise in free climbing in poi. Il livello compositivo ormai è questo, complice anche un Lars che negli anni si è evoluto più come manager che come batterista e un Hetfield sempre sul filo del rasoio nella lotta con se stesso.
Sintomatico è anche il fatto che ai concerti (io li ho visto nel 2022 al Firenze Rock) non ripropongono mai le canzone “dei tempi bui” ma solo i grandi classici. E’ un discorso che vale un po’ per tutte queste band (i Judas non fanno niente dal vivo del periodo “non Halford” così come i Depeche Mode non portano mai niente del periodo Exciter), alla fine ripropongono cosa vuole la gente, per il resto ci sono i dischi.

Per le Pietre Rotolanti invece li avrei fatti fermare al precedente (e validissimo) Blue & Lonesome (2016). Siete dei giganti, io quando sento la chitarra di Richards me la faccio letteralmente sotto, vi siete buttati sulle cover giustamente perché se vi manca il guizzo ci si rifà con il mestiere (oltre che a dei mezzi sostanzialmente infiniti), che quello non si perde ed è più semplice essere interpreti e compositori. Ma visto il buon successo del precedente, mossi anche a compassione per l’improvvisa scomparsa di Charlie Watts (che comunque aveva composto alcune cose nel 2019), ai nostri sono venute strane idee ed hanno partorito il loro ventiquattresimo album in studio.
Quando ho sentito i primi colpi di batteria di Angry (un misto tra Start Me Up e Rain Fall Down) “ho incenerito qualche calendario” (cit.) poi il Pirata ci piazza “quel suono” che solo lui ha e per un po’ mi passa tutto. Jagger si danna l’anima, Richard ci rimette un assolo dei suoi ma resta il fatto che la canzone è sempre un misto di Start Me Up e Rain Fall Down anche se la somma è migliore delle singole parti (almeno la produzione è indovinata, nella seconda canzone è tremenda).
L’album nel complesso non è male, si lascia ascoltare, almeno hanno avuto l’accortezza di essere se stessi con un piglio moderno senza risultare “modernisti” o “giovanilisti” (che tanto i giovani ascoltano lo stesso altro) e cavalcare la moda dell’ultimo momento (autotune a nastro).
Però piantatela con questi duetti dove si fa a gara a chi urla di più. (Sweet Sound Of Heaven con Lady Gaga). Un tripudio saturo di tra trombe, cori e più ne ha più ne metta dove non si capisce più una beneamata mazza!!!
In fondo mi viene spontanea una domanda. Ma non potevano fare un disco che suonasse come Rolling Stone Blues che da sola vale più di tutto il disco? La stessa domanda che mi sono posto quando ho ascoltato Darkside Blues da Patient Number Nine di Ozzy Osbourne (uscito nel 2022), altra produzione immonda insieme al predecessore.

Per rimanere in tema Ozzy, alla fine il grande ritorno migliore è stato proprio 13 dei miei amatissimi Black Sabbath, uscito ormai nel lontano 2013 a chiusura (definitiva) della band in tutte le sue declinazioni. Un album che (ri)prende quei tre o quattro punti fissi della band e li (ri)propone pari pari: la pioggia di End of the Beginning, l’andamento marziale di Loner, le scorribande tremebonde di Live Forever o la fantastica armonica di Damaged Soul (la miglior canzone dell’album). Sì un album ruffiano, privo di un vero colpo di genio ma non dimentichiamoci da dove eravamo partiti. Letteralmente stritolati dagli anni ‘90, riuniti un po’ per disperazione, si erano ritrovati senza batterista (Ward non accetta la rimpatriata per motivi commerciali) e con un linfoma che colpisce Iommi. Disco, tour, qualche video-concerto e tanti saluti, ognuno per la sua strada.

Ma tutto questo pamphlet è dovuto anche al fatto di aver recuperato l’ultimo lavoro degli Immortal dal titolo War Against All (2023), con lo sbandieratissimo ritorno di Demonaz dopo i noti problemi di salute stabilmente a capo del progetto (oltre che alla chitarra). Ne avevo sentito parlare un gran bene di questo disco, con tanto di perculate ad Abbath (l’altro mezzo Immortal) e la sua band, quindi mi sono deciso ad ascoltare questo disco pensando di immergermi in un “true norwegian black metal”. Invece, per dirla alla Sig.rina Silvani, “du palle”. Nel senso che da Wargod in poi le canzoni sono tutte una copia di Tyrants (Sons of Northern Darkness, 2002). Niente di niente, bocciato su tutti i fronti.
Dei poco amati In Flames con Foregone (2023) e di quella “carcassa putrescente” (cit.) dei Katatonia con Sky Void of Stars (2023) meglio non parlarne. La definizione dei secondi la lessi ai tempi di The Great Cold Distance del 2008 (disco con i quali li ho conosciuti), visto la lontananza anni luce con quella perla nera che risponde al nome di Brave Murder Day (1996). A me onestamente son sempre piaciuti tantissimo anche i lavori a cavallo del millennio (Discouraged Ones / Tonight’s Decision / Last Fair Deal Gone Down), ma a questo giro tocca a me usare quella definizione verso una band capace solo di darti qualche ritornello che ti si appiccica alle orecchie per giorni e basta.
Chiudiamo qua la parentesi delle cose brutte (ne dovevo parlare altrimenti sembra che mi piaccia tutto o che riesca a parlare solo di ciò che mi piace) e spendiamo due parole su due dischi validissimi. Il primo è la colonna sonora di Dune Parte 2 realizzata da “che ve lo dico a fare” Hans Zimmer. Un tutt’uno con il film, ma funziona anche benissimo anche da sola, con i suoi droni, le sue torsioni marziali, potente e affascinante al tempo stesso.

L’altro è il nuovo lavoro solista di Kim Gordon, l’esatta metà dei Sonic Youth, gambe lunghe e caschetto biondo per attraversare anch’essa 50 anni di musica. Finito l’amore con Moore nel 2011, così come i Sonic Youth, la Gordon ha realizzato già ben 3 dischi solisti. Onestamente non gli davo una lira, non sapevo che coordinate avesse, l’ho ascoltato al buio ecco. Ne viene fuori un monolite denso e oscuro, cantato dalla Gordon a fil di voce, con la sua elettronica lo-fi conturbante e maliziosa (The Candy House, Psychedelic Orgasm), con chiare influenze di Massive Attack (Shelf Warmer), NIN (It’s Dark Inside) e Swans. Disco notevole, da riascoltare e che credo rimarrà una delle cose migliori di questo anno.

In chiusura è doveroso citare il trentennale di due dischi. Il primo è The Downward Spiral uscito l’8 marzo del 1994. Registrato al 10050 di Cielo Drive in Benedict Canyon (Los Angeles), quel fantastico posto al sole dove la cricca di Manson uccise Sharon Tate nel 1969, rappresenta in musica tutto la mazzetta dei colori con cui il Trent Reznor dell’epoca vedeva il mondo (già i titoli della canzoni son tutto un programma), tra paranoia, alienazione, depressione e perversioni sessuali. Ne verrà fuori uno dei migliori dischi di quel periodo, se non della musica tout court, caposaldo di un genere etichettato come industrial metal. Negli anni Reznor riuscirà a salvarsi, chiudendosi nel mondo delle colonne sonore e realizzando opere di un certo livello. Non un male, mica si deve sempre per forza morire.
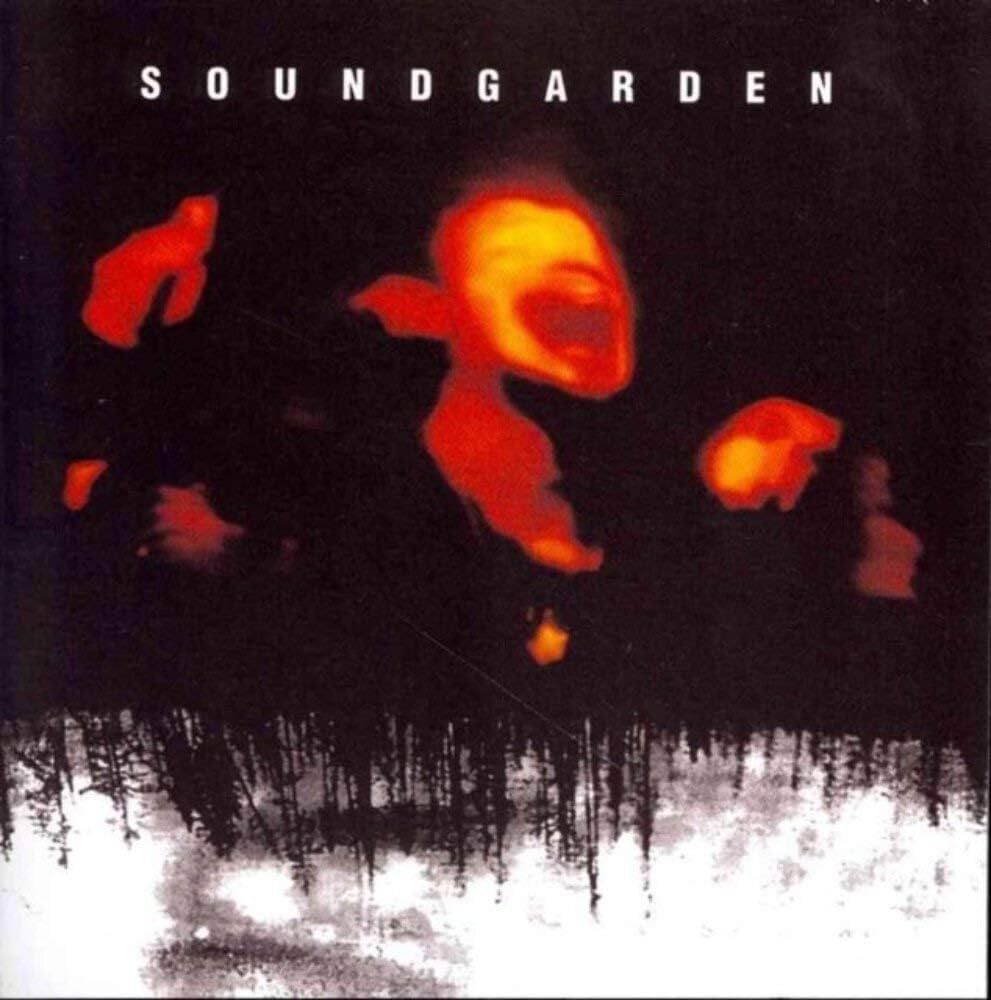
L’altro anniversario è per Superunknown dei Soundgarden, uscito anch’esso l’8 marzo, ovvero il “giorno in cui provai a vivere”. Io sono un cornelliano di rito audiosleviano, se non fosse stato per l’omonimo album di debutto, al di là del suo valore, tutto questo (scritto intendo) non sarebbe probabilmente esistito. La sua scomparsa la percepisco lontana, onestamente non so spiegarmi il perchè. E’ la medesima sensazione che provo verso un altro mito della mia gioventù, il Barone Rosso, ovvero Michael Schumacher. Forse perché ho avuto altre perdite più vicine e questa viene inconsciamente alleggerita, forse perché mi ero un po’ allontanato dalla sua musica (non era difficile), forse perché nel 2007, quando lo vidi all’Alcatraz di Milano, mai avrei pensato che dieci anni dopo si sarebbe suicidato. Era in evidente difficoltà, vocale ed artistica, ritornando con i suoi Soundgarden forse cercava un appiglio sicuro, ma alle soglie dei sessant’anni pensavo ormai che ce l’avesse fatta. O forse la sento lontana perché in realtà non se n’è mai andato ed ogni giorno che suonerà una sua canzone sarà come se l’avesse registrata sul momento. Lo stesso effetto che mi fa un casco rosso che sventola una bandiera con un cavallino rampante sopra.
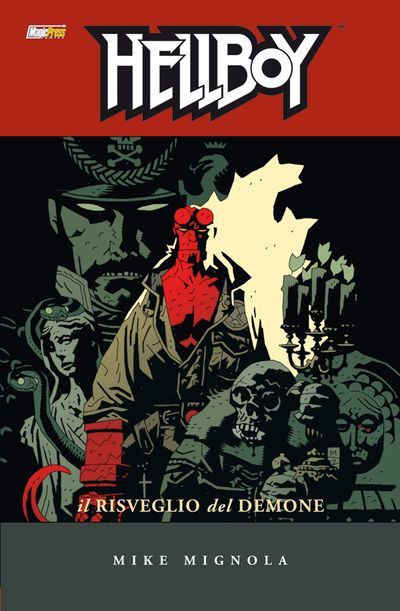



Lascia un commento