Questo mese niente recuperi strani ma mi sono smazzato un po’ di roba uscita in questi sei mesi. Le classiche cose che hai nei “to do”, anzi nella lista “must be done”, quindi ti tappi il naso e vai.

Mi tolgo subito il dente: ascoltando il nuovo dei Pearl Jam, Dark Matter, non ho ancora perso l’uso della tabellina del 2. Pensavo peggio, o meglio, pensavo che anche questo nuovo lavoro sarebbe passato come Gigatron (2020), ovvero completamente inosservato. Gigatron l’ho ascoltato forse una o due volte ed ho avuto la stessa sensazione di quando si è al volante di una macchina e si arriva in un posto ma non abbiamo il benché minimo ricordo di come ci siamo arrivati (ovviamente da sobri).
Quindi mi ero messo in posizione a testuggine pronto all’impatto ma alla fine sono sopravvissuto. Io per i Pearl Jam provo una profonda ammirazione ed anche un briciolo di tristezza: di fatto sono l’unica band uscita dal mare magnum del grunge ad essere “sopravvissuta”, ed il povero Eddie Vedder ha dovuto dire addio a tanti amici, basti pensare a Layne Staley, Andrew Wood e al povero Cornell. Non sono morti di vecchiaia, ma la cosa non cambia di molto il discorso. Riscoprendoli da “grande”, il trio Ten – Vs – Vitalogy se ne sta lì in bella vista, accompagnato da Yeld (mi ricordo di quando andavo alle superiori e la mattina MTV passava sempre il video di Do The Evolution) e Binaural, disco che nonostante i mille difetti, ha qualcosa da dire. Dei successivi, salvo un paio di “momenti” (Inside Job, Sirens) non tengo niente.
Tornando a questa nuova fatica (prodotta da Andrea Watt), l’album regge, anche se appeso ad un filo e da il meglio di sé nella prima parte, mantenendo furbescamente un che di familiare (si può dire “già sentito?”) grazie al duo iniziale Scared of Fear e React, Respond. Nonostante l’impegno, a causa di una produzione che appiattisce tutti gli strumenti, Vedder sembra che sia costretto a rincorrere la musica.
La successiva Wreckage è una ballata alla Daughter mentre la title track Dark Matter rappresenta sì il pezzo più radiofonico del disco, ma è anche quello più centrato, dove a McReady finalmente non scivola l’assolo di mano. Carina anche Upper Hand, con intro alla Underwolrd e con un assolo che tende a fare il verso all’inarrivabile Sleight Of Hand. Da qua l’album crolla e conviene passare al disco successivo.

Quasi quarantacinque anni di attività per gli Einstürzende Neubauten che con Rampen (apm: alien pop music) (2024) arrivano al loro disco numero quindici. Lontani i tempi in cui facevano suonare di tutto, tra industrial e musica di avanguardia. Ma dalla svolta “silenziosa” di Silence Is Sexy (2000), dove per me il migliore rimane Alles wieder offen (2007), questa nuova fatica risulta essere priva di mordente e spessore, salvo Ist Ist e Isso Isso, trascinandosi stancamente fino alla fine.
Nonostante li segua da diversi anni, vedendoli dal vivo all’Estragon di Bologna nel lontano 2007, non ho ancora comprato un loro disco.

Lo stesso discorso vale, con la differenza che non mi ricordo dove gli abbia visti ma il periodo è più o meno quello, per gli italiani Ufomammut che con Hidden (2024) portano a due il numero di album in studio con Levre, che affianca Poia e Urlo, in sostituzione di Vita, uscito dalla band per diverse incomprensioni.
Concedendogli un ascolto attento, l’album risulta curato nel songwriting, cercando di smuovere un po’ le acque, mantenendo sempre una forma granitica ed inossidabile ma adottando una forma canzone più vicina al metal in senso stretto e più lontana dal sabbie oscure di Melvins e Neurosis.
Riprendendo il discorso interrotto con Fenice (2022), l’album si dipana pian pianino con la litania ipnotica di Kismet, passando per il turbine sludge su cui poggia Mausoleum, i cui synth sul finale ricordano qualcosa degli Isis di Oceania e Leeched, dove nelle linee vocali si possono scorgere echi dei primissimi Tool, fino alla lunga coda lisergica di Soulot.
Hidden ci presenta la band piemontese in ottima forma, in un genere non proprio attualissimo. Distribuisce Neurot Recording.
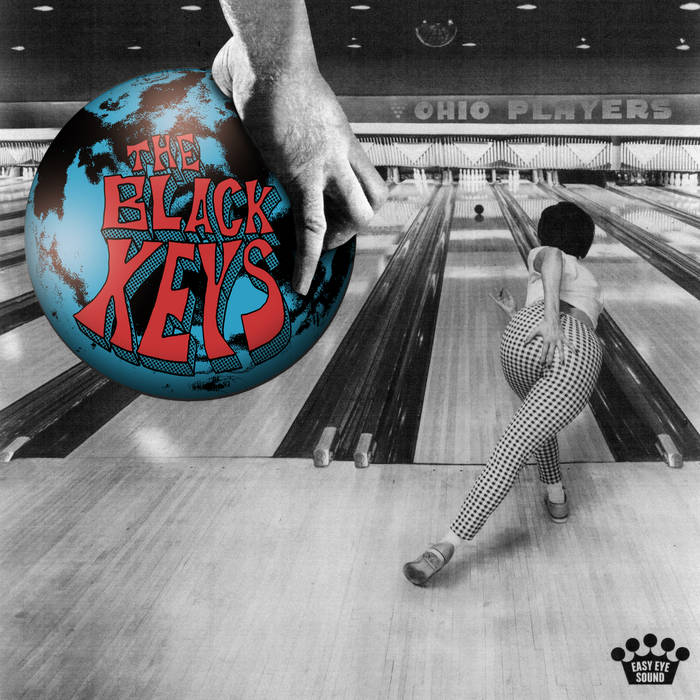
Vi devo fare una confessione. Questo disco l’avevo già ascoltato 2 mesi fa e non sapevo cosa dire. L’ho ascoltato un mese fa e ancora non sapevo cosa dire. Addirittura avevo in mente di pubblicare “la musica di…” il 12 di Giugno invece del 2 proprio per aver più tempo per scrivere di questo disco. Era tutto pronto e mancavano solo loro. Ma alla fine non so proprio cosa dire. Solo che i Black Keys sono una macchina che va con il pilota automatico. Io li conosco dal 2010 con il loro lavoro più raffinato e che li ha fatti conoscere al grande pubblico. Ora sfornano un disco ogni due anni, azzeccando ritornelli (Beautiful People, Dont’ let me go), super pezzi radiofonici (This Is Nowhere). La qualità con cui fanno ciò, di mezzi e di intenzioni, è sempre elevatissima, marchiando a fuoco gli ultimi quindici anni di “radio rock”, grazie anche al tocco prezzemolino di Auerbach in altri lavori (Lana del Ray, Dr. John, Lee Fields).
Anche se poco, ma sono riuscito a dire qualcosa.

Passati i grandi classici si ritorna a qualcosa di più nuovo, dove una è una conferma mentre il secondo è una sorpresa sconosciuta ed abbastanza spiazzante.
Per la sorpresa mi riferisco ai BIG|BRAVE che con A Chaos Of Flower (2024) vanno a confermare il precedente Nature Morte. Canadesi alla ormai sesta prova (ma per me è la seconda non avendoli mai ascoltati), il nuovo batterista Tasy Hudson affianca Robin Wattie alla voce e Mathieu Bernard Ball alla chitarra. Anche qua si propone un monolite sonore fatto da muri di chitarre distorte, impreziosite dalla voce di Wattie, vero elemento distintivo della band, a metà strada tra Chelsea Wolfe e Julie Christmas. Ed è incredibile il livello in cui si riescono ad esprimere, basta prendere Not Speaking Of The Ways, come se i Beach House o i nostri Daughetrs cantassero su di un ossessivo sabba nero.
Promossi anche a questo giro e devo decidermi a riprendere anche i lavori precedenti.

La sorpresa spiazzante invece è Moor Mother, al secolo Camae Ayewa, poeta e attivista statunitense, al suo nono album dal titolo The Great Bailout (2024). Non sono riuscito ancora a capire se è lei a cantare o si affida interamente ad altre voci (come Lonnie Holley e Raia Was in All The Money o al soprano Alya Al Sultani), fatto sta che la traccia di apertura mi sembrava fosse un buon inizio per un disco tra il soul e gospel, poi invece si è rivelato un oggetto particolare, oscuro, disturbante, con questa elettronica fumosa e inquietante, mescolando afrobeat, hip hop e jazz.
L’album narra la vicenda dello Slavery Abolition Act, ovvero l’abolizione della schiavitù da parte del Governo Britannico su tutti i territori dell’Impero. L’indennizzo da conferire agli schiavisti registrati per la perdita del loro bene commerciale fu quantificato in 20 milioni di sterline dell’epoca, cifra che i contribuenti inglese hanno dovuto finanziare fino al 2015, data in cui è stato dichiarato estinto il debito. Ovviamente agli schiavi non è stato conferito nessun indennizzo.
Non pensato come disco, ma riproposizione di un set per alcune occasioni live (tra cui il Macao di Milano nel 2019) è nato con la collaborazione musicale della London Contemporary Orchestra e che non è quindi materiale nuovo per un disco volontariamente sopra righe e poco incline al formato fisico.
Gold Mass – FLARE (2024)
Terzo lavoro (anche se questo ufficialmente è un EP) per l’artista italiana Emanuela Ligarò. Possiamo chiamarla soul dance? Consigliato a chi piace un’elettronica raffinata e che sappia emozionare.
Gary Clarke Jr. – JPEG RAW (2024)
Un uomo un dubbio. Perso quando l’avevano accostato ad Hendrix in un disco in cui sembra più Lenny Kravitz.
High On Fire – Cometh The Storm (2024)
La storia ci dice che quando si sono sciolti gli Sleep (monumentale band stoner rock), Cisneros e Hakius formarono gli Om, mentre Matt Pike creò gli High on Fire. Nel gioco delle coppie Cisneros e Pike si ritrovarono nel 2018 negli Sleep, mentre Hakius lasciò la nuova band senza rientrare in quella nuova (sostituito da Jason Roeder dei Neurosis). Gli High On Fire picchiano come fabbri, proponendo un sound granitico e sfaccettato. Me li sono segnati anche in vista di un recupero più approfondito.
Toadliquor – Back In The Hole (2024)
Gran ritorno, dopo 21 anni, per la formazione sludge / doom americana. Non li conoscevo, ho recuperato anche il loro disco precedente (The Hortator’s Lament) e meritano sicuramente un ascolto per chi è amante del genere.
The Black Crowes – Happiness Bastards (2024)
Seppellita l’ascia di guerra, i fratelli Chris e Rich Robinson per i quarant’anni della band, danno alle stampe questo Happiness Bastards che lascia senz’altro l’amaro in bocca, perché l’ottimo trio folk blues Waiting and Waiting / Wilted Roses / Dirty Cold Sun prometteva bene, ma poi l’album si trascina su classiche canzoni blues rock poco ispirate.
Harvestman – Triptych: Part One (2024)
Primo lavoro di una trilogia per Steve Von Till, mente e cantante dei (defunti?) Neurosis. Mi aspettavo qualcosa più vicino alle sue produzioni soliste, quindi gli ho dato un ascolto con il piede sbagliato.
Devastator – Conjurers Of Cruelty (2024)
Crudo ma trascinante thrash metal influenzato dal seminale black metal dei Venom, Sodom e Kreator in questa secondo prova dei londinesi. Bel tiro senza dubbio, poco estivo e un po’ troppi effetti sulla voce.
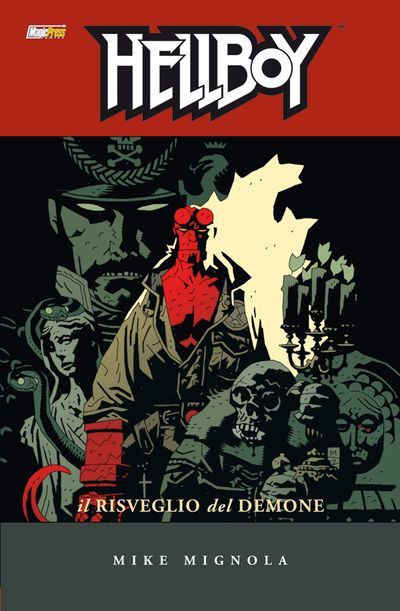



Lascia un commento