Volevo fare un po’ il punto della situazione nel tradizionale mese del giro di boa che è Giugno ma tanto è già tutto su queste pagine quindi ho continuato ad ascoltare cose interessantissime e con la giusta dose di malessere e pesantezza, incoraggiato da un’estate che d’estate ha solo il mese del calendario, io che l’estate l’ho sempre adorata da piccolo ma odiata da grandicello in quanto stagione “in cui si scende in campo” ma io le ferie le avevo a fine Agosto.
Volevo parlare anche del Firenze Rock ma, vista la mia nota lentezza nello scrivere, la musica di Giugno finirebbe per essere letta ed ascoltata a Dicembre. Rimando il tutto ad un ipotetico articolo in cui raggruppare gli eventi live a cui ho presenziato (mannaggia a me mi son scappati gli AC/DC!). Nel frattempo mi sono smazzato un po’ di musica uscita in questo 2024 ma che avevo solo lievemente assaggiato. Andiamo in ordine quasi cronologico (almeno a livello di uscita).

Partiamo dal ventiquattresimo album in studio dei Saxon, uscito alla fine di Gennaio, dal titolo Hell, Fire e Damnation. Ho la sensazione che ad oggi la coppia vecchie glorie & heavy metal sia preferita (e preferibile) alla coppia ragazzi in barba & hard rock. Visto che in entrambi i matrimoni non si inventa nulla, tanto vale andare sul sicuro. E’ il trend del momento (vi ci metto anche dentro gli AC/DC e i Megadeth, giusto per citare due band a caso venute in questa estate in Italia), una ruota che gira e adesso, dopo un paio di decadi nel dimenticatoio, è il turno dei Saxon, dove valgono più o meno le stesse conclusioni fatte per i Judas Priest, band a cui hanno aperto il concerto di Milano lo scorso Aprile.
Niente di trascendentale, sia chiaro, ma i Saxon cercano di fare al meglio quello che sanno fare, ovvero sano e robusto heavy metal senza andare a pescare soluzioni moderne o facendo piedino alla moda del momento. I nostri indovinano il tiro giusto e, forte di una prima parte bella a fuoco con il trio Hell, Fire And Damnation / Madame Guillotine e There’s Something In Roswell, il disco si lascia ascoltare. Radiofonico il giusto, la band capitanata da Peter “Biff” Byford si riprende l’attenzione del pubblico dopo un periodo in cui era caduta nel dimenticatoio, con la speranza che questo nuovo lavoro li possa far conoscere anche chi si è perso i primi fondamentali album come Wheels of Steel (1980), Strong Arm of the Law (1980) Denim and Leather (1981) e Power & the Glory (1983).

Segue il nuovo lavoro degli Idles, che con TANGK arrivano all’album numero cinque, a tre anni dall’ottimo CRAWLER, album che gli ha definitivamente consacrati. Strana creatura questo TANGK (parola onomatopeica che ricorda il suo della plettro sulla corda della chitarra), calderone post punk che vuol dire sostanzialmente post-tutto. Con Nigel Godrich (Radiohead) alla produzione, il disco riproduce l’animo tormentato del suo cantante (nonché paroliere) Joe Talbot, in una creatura sonora che cerca da una parte di mantere le sfuriate muscolari dei lavori precedenti (Gift Horse e Dancer, con lo zampino del LCD Soundsystem) ma che ricerca una stratificazione sonora per poter esplorare terreni ancora sconosciuti, come l’intreccio di batteria tribale e riff rock ‘n roll anni ‘70 in Roy o le atmosfere di Gospel, fatte di pianoforte tra synth ed archi, passando per l’electro dance di POP POP POP e del blues slabbrato di Jungle.

Uscito nel medesimo periodo è il sesto lavoro per i The Amazing dal titolo Piggies. Seguo la band svedese sin dai tempi di Picture Of You, che con la sua Winter Dress fu la colonna sonora di quell’anno orribile che fu il 2015. Dopo cinque anni di silenzio ed un lungo tour, la band svedese torna a suonare su disco e l’opener Streetfighter ci porta immediatamente nelle atmosfere classiche del gruppo svedese, con l’aggiunta di una voce femminile (quella di Lisa Isaksson). Nonostante una proposta abbastanza omogenea e senza grossi colpi di scena, resta prezioso il dream pop della title track o l’ottimo intreccio new wave di basso e tastiere in Last Stand, con la sempre ottima voce di Christoffer Gunrup.

Chiude questo quartetto il nuovo lavoro di Paolo Spaccamonti, Nel Torbido seguito del già ottimo Vol. 4 (2020). Dopo varie collaborazioni con il mondo del cinema, creando sonorizzazioni dal vivo di film muti prodotte dal Museo Nazionale del Cinema di Torino (sua città natale) ed il fortunato tour teatrale di Lazarus, il musical scritto da Enda Walsh e David Bowie (diretto in Italia da Valter Malosti), Spaccamonti torna a cimentarsi con un lavoro solista, un viaggio di 30 minuti nelle pieghe espressive della chitarra. La contaminazione con il cinema resta lo stesso forte, basti pensare a Nel torbido, titolo preso in prestito da una battuta di Tony Curtis nel film del 1959 Operazione sottoveste («Nel torbido si pesca meglio») che inizia con echi alla Neubauten per poi virare su atmosfere care all’ultimo Ben Frost. Ed anche la sinistra I Sogni Non Servono (una frase attribuita al padre) potrebbe stare bene in un film di Dario Argento. Sempre al calar del sole si rivolge l’ultima traccia, Ha ragione la notte (frase di Emmanuel Carrère dal libro Yoga) con la preziosa collaborazione agli archi di Julia Kent.
Dalla novità recenti escono fuori i migliori lavori anche in ottica annuale, con il seguente trio.

In primis il ritorno dei Pallbearer con il nuovo album Mind Burns Alive. Li avevo conosciuti con il precedente Forgotten Days (2020) del quale ho un meraviglioso ricordo, in quanto mi capitava di ascoltarlo spesso mentre tenevo in collo Ada dormiente in attesa che sua sorella si addormentasse per poterla mettere nel suo lettino. Sin dalle prime note di Where The Light Fades, si capisce che la band inglese abbia intrapreso un percorso evolutivo che li sta portando in territori diversi rispetto non solo agli esordi, ma anche al disco precedente, lavorando sapientemente per sottrazione, utilizzando le chitarre come muro sonoro per elevare il songwriting (come ad esempio in Signals e Endless Place, quest’ultima impreziosita anche da un meraviglioso sassofono). Ne viene fuori un album intenso e struggente, dove vengono affrontati temi importanti come nevrosi, depressione, isolamento, deliri da esaurimento maniacale dove per stessa ammissione del cantante Brett Campbell “la vera pesantezza deriva dal peso emotivo, e a volte il puro randellamento non è l’approccio giusto per trasmettere un sentimento”.

L’altro tassello importante è l’esordio dei newyorkesi Castle Rat con Into The Realm, capitanati da Riley Pinkerton, ricciola rossa dalla curiosa pettinatura anni ‘60, dalle forme interessanti in maglia a rete intenta a maneggiare affilatissimi spadoni. I nudi in copertina non mi sono piaciuti, tende a distogliere l’attenzione in una sorta di “mettiamo subito in evidenza ciò che abbiamo di meglio” e siccome il discorso vale per quella gnocca illegale di Elodie come per l’elegante Ana Popovic, non vedo perché non dovrebbe valere anche per la nostra The Rat Queen. Ma in definitiva la voce c’è, i riff sabattiani pure, quell’aria da heavy-psych polveroso e mal prodotto dei primi anni Settanta anche e le canzoni pure (Dagger Dragger, Feed The Dream, Cry For Me, Fresh Fur), non vedo perchè non si possa manifestare gioia e giubilo dai propri balconi. Non vorrei fosse solo un bluff e un elegante “se a semo divertiti” ma a me hanno ricordato i Messa. E sto.
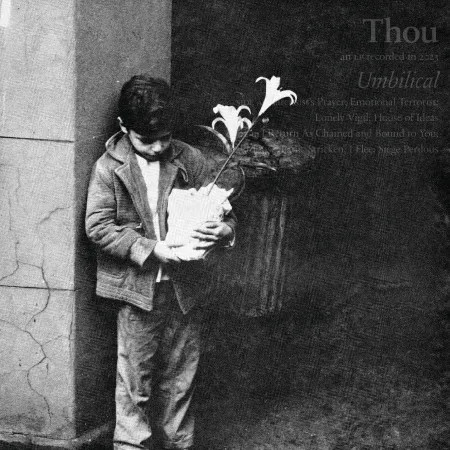
Chiude, e la chiusura è veramente un mattone, il ritorno in versione solista dei Thou con Umbilical. La band americana mi era capitata di ascoltarla nell’ottimo split con Emma Ruth Rundle (May Our Chambers Be Full, 2020) ma nella nuova loro sesta fatica in studio ci propongono quasi un’ora di una miscela fatta di doom, sludge e stoner, creando un sound monolitico inserito in una atmosfera ai limiti del black metal. Tra volumi assordanti, potenti esplosioni, ritmi forsennati e la voce indemoniata di Bryan Funck il risultato è un frastuono infernale che non lascia scampo all’ascoltare. Forse The Promise accenna un vago ritornello, ma siamo alla terz’ultima traccia.
Sul versante recuperi del passato, sostanzialmente ci sono da nominare 2 dischi, diversissimi tra loro.
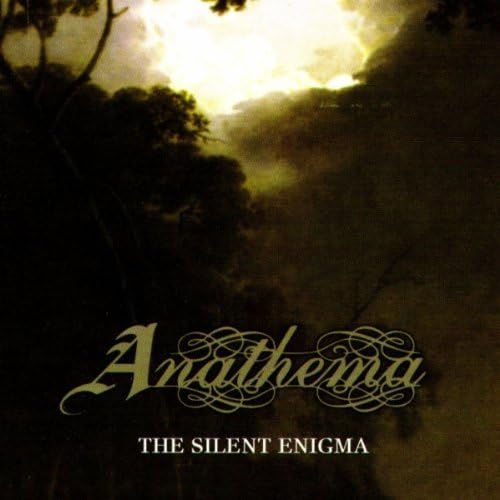
Il primo è The Silent Enigma degli Anathema (1995), l’esordio senza il cantante originario, Darren J. White, sostituito dal minore dei fratelli Cavanagh. Difficile rimanere indifferenti alle atmosfere desolate ed opprimenti nelle lunghe composizioni come Restless Oblivion, Shroud of Frost, A Dying Wish o al meraviglioso ed ipnotico giro di basso in Nocturnal Emission. Il canto sofferto e disperato di Vincent Cavanagh, in un misto di doom/gothic che ricorda alcuni momenti dei Type O Negative e Cure, cerca di smarcarsi leggermente dal death metal degli esordi per momenti più orchestrali e melodici, per una band che cambierà pelle più volte negli anni. Ottima anche Sleepless96, inserita nella remastered del 2003. Ne scaturisce un ascolto ostico proprio in virtù della sue atmosfere decadenti, per uno degli album più significativi degli anni ‘90.

Mentre il secondo è Powertrip (1998) dei Monster Magnet. Sempre sentiti nominare, ma mai ascoltati seriamente, la band capitanata da Dave Wyndorf rappresenta uno dei punti cardine dello stoner lato hard rock (Led Zeppelin, ZZ Top) e meno acid heavy, per un album che ne decretò definitivamente il successo commerciale. Powertrip, con il suo approccio più pulito ed agile ma non per questo meno potente, unito a ritornelli catchy ed immediati, porterà alla ribalta la band americana, grazie anche il super singolo Space Lord. Mentre Dave Wyndorf canta di vizio e perdizione io devo recuperare i vecchi lavori.

Sul versante recuperi più freschi, è curioso il modo in cui ho trovato i seguenti album. Il primo, Vital dei BIG|BRAVE è capitato mentre stavo sistemando la lista degli album del 2021 per tirarne fuori una classifica. Il secondo Etemen Ænka dei DVNE l’ho trovato sempre in quella lista mentre ascoltavo il suo successore (Voidkind, 2024). Il terzetto canadese ormai da queste parti è ampiamente conosciuto, ed è significativo di come avessi già adocchiato questa band già 3 anni fa. Ascoltandoli al contrario, con Vital si capisce come la band canadese stesse gettando le basi per l’attuale sound, un pachiderma doomgaze di scuola Swans e Jarboe, un torbo sabba nero di chitarre distorte che si mescolano a droni, riverberi, archi e campanelli per un netto stacco rispetto agli album precedenti.

I DVNE sono una creatura che ancora devo collocare. L’origine del nome è già tutto un programma (hai detto F. Herbert?) per una sorta di progressive metal molto derivativo, tra Mastodon e Gojra. L’album rende al meglio nelle lunghe composizione come Omega Severer, strutture labirintiche della durata di quasi 10 minuti dove sono protagoniste le voci e le chitarre dei cantanti-chitarristi Victor Vicart e Dan Barter mentre con Towers si fa un salto nello sludge per poi andare a pescare a pieni mani nel post metal prima e nel post rock su finale. Da mettere definitivamente a fuoco anche perchè il disco dura più di ora.
Lolina – Unrecognisable (2024)
Elettronica piuttosto strana
Defects – Modern Error (2024)
La roba metalcore anche no!
Vastigr – The Path Of Perdition (2024)
Bah, credo sia la solita roba da metalitalia.com
meth. – Shame (2024)
Una bella riunione condominiale
Twin Tribes – Pendulum (2024)
Il classico album new – wave annuale (ma non il migliore del momento)
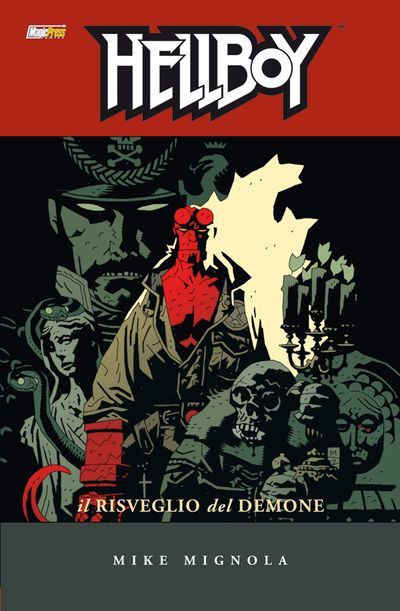



Lascia un commento