
Non c’è niente da fare. Sono un tecnico, se delle cose seguo un ordine, ne tengo traccia, allora tutto acquista un senso diverso. Seguendo questo schema, ho ascoltato musica con la solita intensità di qualche anno fa. L’essere usciti dalla pandemia è stato comunque decisivo, non solo per la parte live (in quel mondo i problemi sono ben altri) ma anche per la parte in studio.
Come sempre ho cercato di coprire tutte le nuove uscite, con l’occhio fisso sulla parte rock (nella sua concezione più spigolosa) e metal (per la maggiore nelle sue declinazioni death e black). Se nel primo i sentieri sono abbastanza esplorati esplorati (ho dato una rinfrescata alle cose meno famose dei Priest e alla produzione fine ’80 / primi anni ’90 dei Motorhead e degli Iron Maiden), è nel secondo che ancora le nozioni sono ancora piuttosto frammentate. Quel tipo di musica lì, quella che viene dal freddo e dal gelo, è una musica relativamente nuova, che si è auto influenzata nel corso del tempo, spesso di non facile appeal almeno nelle prime battute. Insomma aver già passato gli Emperor (dopo Bathory, Burzum e Death) è stato un buon traguardo.
Sostanzialmente è stata una buona annata, i dischi qua sotto ne sono una prova. La varietà c’è stata, le parti positive sono il livello qualitativo dei lavori al femminile (Beth Gibbons, Kim Gordon, Chelsea Wolfe ma anche Billie Eilish, Julia Christmas e Joan As A Police Woman), mi è mancato solo qualcosa nella parte elettronica drone gaze et simili.
Ci sono state anche qualche delusione (Pearl Jam e Einstürzende Neubauten), qualche ottimo come back (Jesus Lizard, Jack White) e qualche disco interlocutorio (Blood Incantation)
Manca ancora qualcosa, ci sono dei lavori che sono usciti da poco o che non avuto ancora modo di ascoltarli e non volevo forzare l’ascolto solo per poterli inserire in classifica; parlo di Ben Frost, Michael Kiwanuka, Rafael Anton Irisarri, Jamie xx, Ulver. Li riprenderò senz’altro nei classici recuperi di fine anno.
Ho pure anche recuperato i primi lavori del nostro amato Reverendo, cioè Marilyn Manson! Poi vi dirò…
Sul fronte live, ci sono stati il Firenze Rock con i Tool e i Judas Priest al Forum di Assago. Direi non male, ma mi sono perso qualche concerto minore nella seconda parte dell’anno (Daniela Pes, Slift). La distanza e la pressoché inesistente compagnia non mi da più quell’entusiasmo di una volta per coprire certi eventi.
Detto questo, ecco i miei 20 dischi preferiti per l’anno appena trascorso. I criteri sono sempre gli stessi. Un disco per autore, niente best of e rifritture varie. E, salvo il podio, l’ordine delle restanti posizioni non ha molta importanza. Diciamo che per le prime dieci posizioni cerco in genere di lasciarle, ove possibile, alle “nuove proposte” mentre le altre 10 li lascio per gli amatori, vecchie glorie ed “rieccoli” vari.
Ma andiamo con ordine. Come on guys!
20. Hans Zimmer – Dune: Part Two

Come da tradizione l’ultima posizione va sempre ad una colonna sonora. La partita si è chiusa già all’inizio dell’anno con l’uscita di Dune Parte 2 di Denis Villeneuve la cui colonna sonora è stata realizzata da, che ve lo dico a fare, Hans Zimmer. Un tutt’uno con il film, ma funziona anche benissimo anche da sola, con i suoi droni, le sue torsioni marziali, potente e affascinante al tempo stesso.
19. Primus, Puscifer, A Perfect Circle – Sessanta E.P.P.P.

Piccolo progetto su cui non avrei scommesso “la classica Goleador alla frutta” è Sessanta E.P.P.P. Un Ep di tre canzoni (una a testa) di Perfect Circle, Puscifer e Primus, cantate da Maynard James Keenan per i suoi sessant’anni (17 aprile 1964). Se la copertina è a metà tra qualche fumetto anni ‘70 e gli Sgorbions, gli APC rimangono nel solco di Eat The Elephant, con una canzone composta “per piano” con il ritorno di Josh Freese alla batteria, dove il buon Maynard infila con estrema naturalità una strofa delle sue. (A delicate age for such a numb / For loss and lesson / Momentary, fleeting and brief / A nature of all connection). Non da meno anche No Angel dei Puscifer, mentre Pablo’s Hippos con i Primus alleggerisce un po’ l’atmosfera.
18. Judas Priest – Invincible Shield

Dopo il validissimo Firepower del 2018, anche in questo Invincible Shield i nostri alfieri dei metal tutto pelle e borchie non si risparmiano in niente, dal tiro indiavolato, al groove, nei volumi e nella durata. Trovata la quadra nella line-up, con il Metal God in formissima insieme alla collaudata coppia Hill – Travis, risultano fondamentali gli innesti dei due “giovanotti” Richie Faulkner (già nei Priest dal 2011 in sostituzione di K.K. Downing uscito dalla band per varie divergenze) e Andy Sneap, il produttore di Firepower e sostituto di Glen Tipton nei live in quanto affetto dal morbo di Parkinson. Seppur accreditato, a causa della malattia, Tipton riveste sempre più un ruolo marginale nella band ed anche in studio diverse parti sono state composte e suonate dallo stesso Sneap.
Come detto, l’album si presenta con un bel bagno di fuoco a firma Judas Priest, con il trio schiacciasassi Panic Attack / The Serpent and the King / Invincible Shield lanciato a tutta manetta.
L’album si snoda sulla pachidermica Devil in Disguise (che nella parte centrale fa il verso a Metal Gods) alle sfuriate quasi trash di As God Is My Witness mentre Crown of Horns, è stato il primo singolo che ho ascoltato ed ero rimasto un po’ a mezza via, perché mi sembrava il classico pezzo pop rock innocuo con tanto di assolo telefonatissimo. La penso sempre così, ma dal vivo (visti dal vivo il 6 Aprile al Forum di Assago, insieme ai Saxon e a Phil Campbell e suoi figli bastardi), la canzone è diventata un’altra cosa ma su disco è così e tale rimane. Escape for reality (ed in parte Sons of Thunder), seppur non malaccio, pagano qualche effetto alla voce vicino un po’ a qualche produzione Ozziana&Sabbathiana degli ultimi tempi.
La parte finale è quella che preferisco (che nella Deluxe è quella centrale visto che sono presenti altre 3 canzoni), con Trial By Fire e Giant In The Sky a farle da padrone. In sostanza un buon disco heavy metal che ci presenta la seconda (ma anche la terza o la quarta…) vita di una band storica in buona forma. Non era scontato.
17. Moby – Always Centered At Night
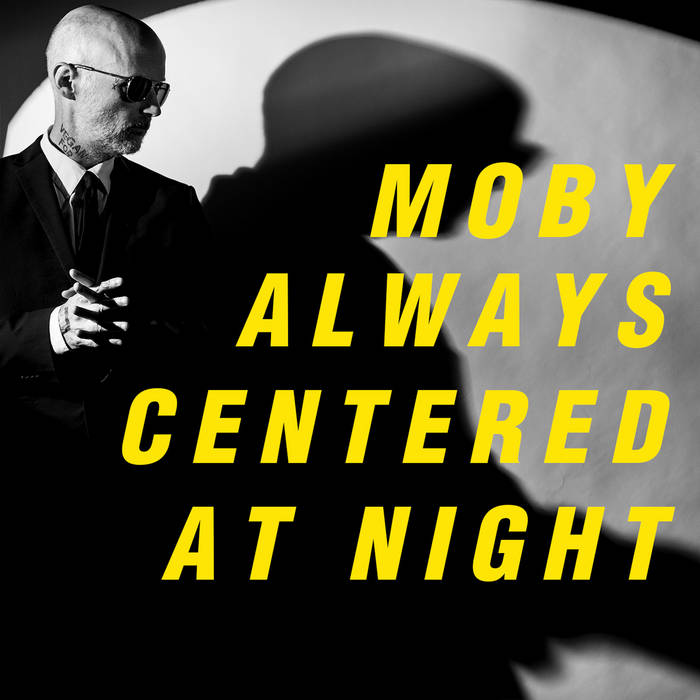
Essendo un ex discotecaro che si è dato un tono, la “sorpresa delle sorprese” non poteva che essere “di movimento”. E perché non scegliere il ritorno di Moby con Always Centered At Night? Un bel disco, lontano dalla forma migliore dei primi anni ma più a fuoco rispetto alle ultime uscite, il buon Richard Melville Hall firma un bell’album dalle atmosfere downtempo, quasi dub (la opener sta tra James Blake e The Weeknd), ricche di contaminazioni gospel, jazz e R&B, contornato anche da performer di altissimo livello (Lady Blackbird ad esempio). Promosso.
16. Skeletal Remains – Fragments of the Ageless

Di dischi così ne ho ascoltati diversi negli ultimi due anni, cercando un po’ di sparare nel mucchio in un genere, quello del metal più estremo (chiamatelo death o come vi pare), di cui ho ancora una evidente carenza. Ma ci arriveremo. Proprio per questo ho inserito il quinto disco della band statunitense, come se fosse un piccolo Bignami, visto che riprende parte del death metal di metà anni ‘90 (Deicide e Morbid Angel in particolare) in un susseguirsi di riff abrasivi e taglienti. Speriamo che sia anche di spunto per andare a recuperare anche le band da cui tutto è iniziato.
15. The Cure – Songs Of A Lost World

Non mi ritengo un fan della band di Robert Smith in senso stretto, anche se considero Disintegration una della miglior cosa mai suonate dal genere umano. Ma posso ben immaginare lo stato d’animo di chi, arrivati al minuto 3:22, sulle parole “This is the end of every song that we sing” si sia sentito di nuovo a casa.
Ritornano così i Cure, dopo ben 16 anni dall’ultima volta, su disco. Un album ampiamente annunciato nel tempo, dalla genesi live (5 brani su 8) per poi essere raffinato in studio. Un album che guarda alle sonorità di fine anni 80 / inizio 90, così cupe, solenni, con quelle chitarre così slabbrate e granulose, che trovano il loro apice nell’accoppiata centrale Warsong / Drone:Nodrone. Ma che non rinuncia a squarci di leggerezza nella quasi sigurossiana And I Nothing Is Forever e A Fragile Thing, con il suo ritornello appiccicoso.
A 65 anni Robert Smith, con la sua figura burtoniana ed un pesante fardello di lutti alle spalle (la perdita dei genitori e del fratello Richard, a cui è dedicata I Can Never Say Goodbye), non rinuncia alla sua musica, prendendosi tutto il suo tempo nella conclusiva Endsong.
Mi piacerebbe vederli dal vivo, che te lo dico a fare.
14. Ottone Pesante – Scrolls Of War

Sempre sentiti nominare ma mai ascoltati (forse confusi con Oranssi Pazuzu), gli Ottone Pesante sono una band faentina formata da Paolo Ranieri (tromba), Francesco Bucci (trombone) e Beppe Mondini (batteria).
Il titolo dell’album prende spunto dai “Rotoli di Guerra”, antichi testi contenuti nei Manoscritti del Mar Morto rinvenuti tra il 1947 e il 1956 nelle Grotte di Qumran e datati tra il 150 a.C e il 70 d.C., in cui vengono narrati di come le forze del bene sconfiggeranno il male e del ruolo chiave di trombe e corni suonati dai sacerdoti sul campo di battaglia.
Ne viene fuori un heavy brass metal, una commistione tra metal (nelle sue declinazioni più oscure), progressive, jazz e avantgarde. Un groove pesantissimo, un ritmo forsennato, in cui si finisce per essere sommersi in un mare di riverberi, distorsioni e spoken word. Un picco sonoro che tocca il culmine nell’aria struggente di Men Kill, Children Die e nella meravigliosa collaborazione con Lili Refrain (recuperate Mana del 2022) In Battle of Qadesh, vero snodo dell’album.
Un disco non da tutte le stagioni, ma mi è sembrato doveroso metterlo in risalto, visto la scarsa rappresentanza italica di quest’anno.
13. Nicole Marxen – Thorns

Buttiamoci dentro un esordio, nello specifico quello della misteriosa Nicole Marxen con il primo album sulla lunga distanza dal titolo Thorns. Con una scarna biografia (originaria di Dallas, è una musicista ed artista visiva da due decenni) la nostra si colloca dalle parti più heavy Chelsea Wolfe, offrendo un appassionato intreccio di dark wave dal sapore ottantiano, oscuri synth e divagazioni dream pop. La Marxen come si suol dire se la suona e se la canta coadiuvata da Alex Bhore, compositore delle soundtrack di Halo Infinite e batterista dei I Will Destroy You.
12. Pallbearer – Mind Burns Alive

Sin dalle prime note di Where The Light Fades, si capisce che la band americana abbia intrapreso un percorso evolutivo che li sta portando in territori diversi rispetto non solo agli esordi, ma anche al disco precedente, lavorando sapientemente per sottrazione, utilizzando le chitarre come muro sonoro per elevare il songwriting (come ad esempio in Signals e Endless Place, quest’ultima impreziosita anche da un meraviglioso sassofono). Ne viene fuori un album intenso e struggente, dove vengono affrontati temi importanti come nevrosi, depressione, isolamento, deliri da esaurimento maniacale dove per stessa ammissione del cantante Brett Campbell “la vera pesantezza deriva dal peso emotivo, e a volte il puro randellamento non è l’approccio giusto per trasmettere un sentimento”. Una band da maneggiare con cura.
11. Thou – Umbilical

Il premio “mattone”: il ritorno in versione “solista” dei Thou. La band americana mi era capitata di ascoltarla nell’ottimo split con Emma Ruth Rundle (May Our Chambers Be Full, 2020) ma nella nuova loro sesta fatica in studio ci propongono quasi un’ora di una miscela fatta di doom, sludge e stoner, creando un sound monolitico inserito in una atmosfera ai limiti del black metal. Tra volumi assordanti, potenti esplosioni, ritmi forsennati e la voce indemoniata di Bryan Funck il risultato è un frastuono infernale che non lascia scampo all’ascoltare. Forse The Promise accenna un vago ritornello, ma siamo alla terz’ultima traccia.
10. Sumac – The Healer

Il premio “io sono io e voi non siete un”: il ritorno dei Sumac con The Healer (2024). La band capitanata da Aaron Turner (ex Isis al quale, si sa, io pagherei anche le bollette di casa) affiancato da Brian Cook (Russian Circle) e Nick Yacyshyn (Baptists) continua a registrare fermamente i propri lavori oggettivamente incollocabili e difficilmente inquadrabili. Un’idea estraneamente personale di avantgarde-metal, dove nelle lunghe quattro composizioni le coordinate sono diverse da quelle delle band madri e si passa a momenti prettamente sludge metal, a muri di chitarra in salsa noise demoliti dal growl di Turner, al tribalismo tentacolare di Yacyshyn alle pelli. Un lavoro del genere sta stretto su disco, figuriamoci ridotto in forma testuale. Quindi il consiglio è quello di ascoltarlo con serenità.
9. Chelsea Wolfe – She Reaches Out To She Reaches Out To She

Forte di una stima pressoché infinita da parte sia di chi la segue sia dalla critica in senso stretto (nel giro di qualche giorno tutte le sei webzine che seguo hanno parlato del disco), la cantautrice di Sacramento, con She Reaches Out To She Reaches Out To She (il suo settimo album uscito stavolta per la semi indipendente Loma Vista) può sostanzialmente fare ciò che vuole. A questo giro adotta un suono più orizzontale, abbandonando le scorribande heavy degli ultimi anni ma fabbricando, grazie alla commistioni con generi diversi come il trip hop e la dark ambient, ottime composizioni a tinte scure su cui poggiare liberamente la propria vocalità, per un album che racconta la fine di una dipendenza (la sua) dall’alcool e di un amore tossico (raccontato da un’amica).
8. Kim Gordon – The Collective

Un altra che può fare ciò che vuole è Kim Gordon, l’esatta metà dei Sonic Youth, gambe lunghe e caschetto biondo per attraversare anch’essa 50 anni di musica. Finito l’amore con Moore nel 2011, così come i Sonic Youth, la Gordon ha realizzato già ben 3 dischi solisti. Onestamente non gli davo una lira, non sapevo che coordinate avesse, il classico ascolto al buio. Ne viene fuori un monolite denso e oscuro, cantato dalla Gordon a fil di voce, con la sua elettronica lo-fi conturbante e maliziosa (The Candy House, Psychedelic Orgasm), con chiare influenze di Massive Attack (Shelf Warmer), NIN (It’s Dark Inside) e Swans. 7.
7. Hauntologist – Hollow

Progetto parallelo di Darkside e The Fall, già membri dei Mgła. Partendo dalle coordinate della band madre, il duo cerca comunque di trovare la propria strada andando ad aggiungere ad un solido black metal (Ozymandian, Autotomy) deviazioni post rock e neo folk (Gardermoen, Hollow, Car Krukow) (dark, quasi ulver)
Un progetto coraggioso e riuscito, per questo degno di menzione.
6. BIG | BRAVE – A Chaos Of Flower

Ritorno come lo scorso per i BIG|BRAVE che con A Chaos Of Flower vanno a confermare il precedente Nature Morte. Canadesi alla ormai sesta prova (ma per me è la seconda non avendoli mai ascoltati), il nuovo batterista Tasy Hudson affianca Robin Wattie alla voce e Mathieu Bernard Ball alla chitarra. Anche qua si propone un monolite sonore fatto da muri di chitarre distorte, impreziosite dalla voce di Wattie, vero elemento distintivo della band, a metà strada tra Chelsea Wolfe e Julie Christmas. Ed è incredibile il livello in cui si riescono ad esprimere, basta prendere Not Speaking Of The Ways, come se i Beach House o i nostri Daughetrs cantassero su di un ossessivo sabba nero.
Promossi anche a questo giro e devo decidermi a riprendere anche i lavori precedenti.
5. Coltaine – Forgotten Ways

I Coltaine nascono in Germania, nel 2022 con un formazione di perfetti sconosciuti: Julia Frasch (voce), Moritz Berg (chitarra), Amin Bouzeghaia (batteria) e Benedikt Berg (basso).
Formatisi nel 2022 nella Foresta Nera, le loro creazioni sono piccoli microcosmi di psichedelia oscura e atmosferica (Dans Un Nouveau Monde, Cloud Forest) un acid rock nebbioso (Forgotten Ways) e tinto di post metal (la opener Mogila) con le tinte cupe del blackgaze (Tales Of Southern Lands, Grace).
Siamo dalle parti degli Acid King, dei Messa (ai quali hanno aperto il tour del 2023) o degli Ufomammut più onirici.
Uno dei miglior debutti dell’anno.
4. DVNE – Voidkind
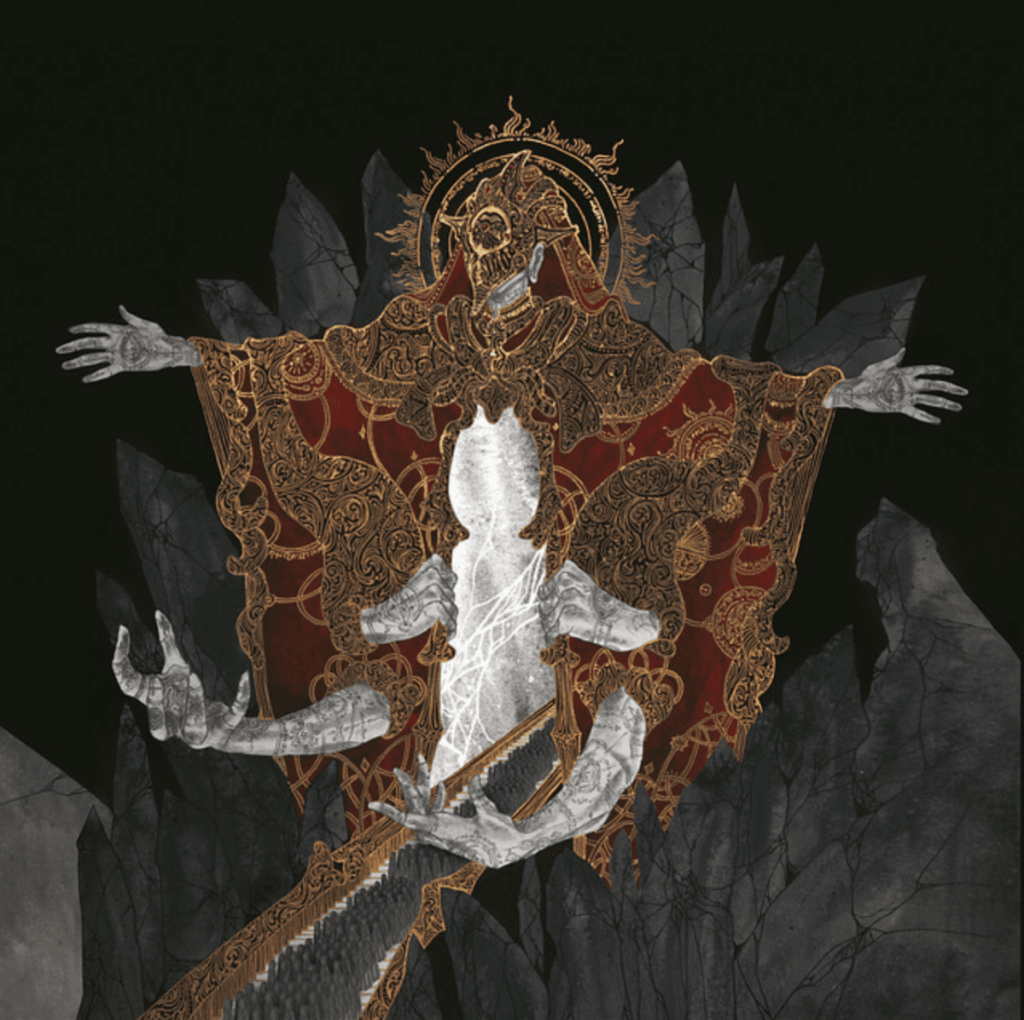
Un posto ai piedi del podio per i misteriosi DVNE. L’origine del nome è già tutto un programma (hai detto F. Herbert?), la band scozzese propone una sorta di progressive metal molto derivativo, tra Mastodon e Gojra.
Con Voidkind, dove continuano ad essere protagoniste le voci e le chitarre dei cantanti-chitarristi Victor Vicart e Dan Barter, confermano quanto di buono fatto nel precedente Etemen Ænka. Le coordinate rimangono sempre le medesime ma a questo giro la band fa ancora meglio, compattando maggiormente il suono rendendolo sempre “chitarrocentrico” ma senza gli intermezzi del disco precedente, mantenendo un sound potente (anche troppo) e magmatico, che punta ai Mastodon e Neurosis meno derivativi degli ultimi anni.
3. Beth Gibbons – Lives Outgrown

Inevitabile parlare dell’esordio in solitaria della voce dei Portishead, Beth Gibbons, dal titolo Lives Outgrown. Tralasciando le sperimentazioni con la band madre, stavolta la Gibson gioca con gli arrangiamenti, gli strumenti, la melodia e con la voce, per una sorta di chamber pop intimista.
Nel trittico Tell Me Who You Are Today / Floating on a Moment / Burden of Life, si capisce quale sarà il mood del disco, tra chitarra acustica, percussioni ed archi. Ma è nella parte centrale che il disco da il meglio di sé, sia con le meravigliose aperture di Lost Changes che con i tribalismi di Rewind e Beyond the Sun, fino a Reaching Out ed Oceans che per arrangiamenti e prestazione vocale sono le migliori composizioni del mazzo.
La stessa Gibbons ha dichiarato di aver scritto questo disco nell’arco di un decennio, affrontando temi specifici del suo percorso di vita in prossimità dei 60 anni, tra cui “la maternità, l’ansia, la menopausa e la mortalità”. Gibbons ha dichiarato che l’album è stato direttamente influenzato dalla morte di familiari e amici avvenuta negli anni precedenti e che “si è resa conto di come fosse la vita senza speranza”.
2. Ulcerate – Cutting The Throat Of God

Il ritorno dei neozelandesi Ulcerate con Cutting The Throat Of God segna per me l’aver messo più di un piede in un genere sostanzialmente nuovo; una sorta di death metal con venature progressive.
Seppur con poche basi con le quali analizzarlo, il nuovo lavoro di Jamie Saint Merat e soci si è dimostrato subito un monolite pieno di contrazione/distensione, con lunghe canzoni che piano piano si dipanano in sfuriate post – death (la maestosa To Flow Through Ashen Hearts), con una sezione ritmica magmatica e una growl opprimente e spiazzante. Un sound chirurgico, che risplende anche in tutte le sue pause (le meravigliose chitarre di The Dawn Is Hollow e Undying as an Apparition) e le sue torsioni (Cutting The Throat Of God).
Non li conoscevo, li ho ascoltati perché avevo letto bene e che sostanzialmente fanno un campionato a parte, unendo tradizione a quel tocco personale che li fa sempre risaltare ad ogni nuovo lavoro.
1. SLIFT – Ilion

Disco uscito subito nei primi mesi dell’anno, salito sulla vetta e mai più sceso. Sto parlando di Ilion, terza fatica dei francesi SLIFT. Un trio formato dai fratelli Jean (voce e chitarra) e Remi Fossat (basso) più il vecchio compagno di scuola Canek Flores (alla batteria), attivi dal 2016.
Già con la opener (che da il titolo al disco) e la successiva Nimh, due panzer lanciati a velocità supersonica, si capisce già cosa si respirerà nel disco, un mix esplosivo di heavy metal, stoner e rock psichedelico. Ai primi ascolti mi hanno ricordato i King Gizzard and The Lizard Wizard e i dimenticati (a torto) Minsk, attingendo un po’ da tutto il “post” di casa Neurot / Relapse.
Con i successivi ascolti è venuta fuori anche la loro personalità perché a i ragazzi non sono solo rumore, sanno maneggiare la materia come si deve. Basti ascoltare The Words That Have Never Been Heard, con suoi strappi e improvvisi cambi di ritmo, dal progressive al jazz, o la meravigliosa seziona ritmica di Confluence, così tentacolare nei suoi cinematismi, impreziosita dal sassofono di Etienne Jaumet. Senza dimenticare le scorribande di The Story That Has Never Been Told e il dark noise di Enter The Loop.
Canzoni vive che nonostante i tanti cambi di ritmo mantengono un tiro altissimo, un groove pazzesco e denotano, oltre che a saper suonare, una grandissima capacità compositiva da parte dei ragazzi di Tolosa. Chapeau!
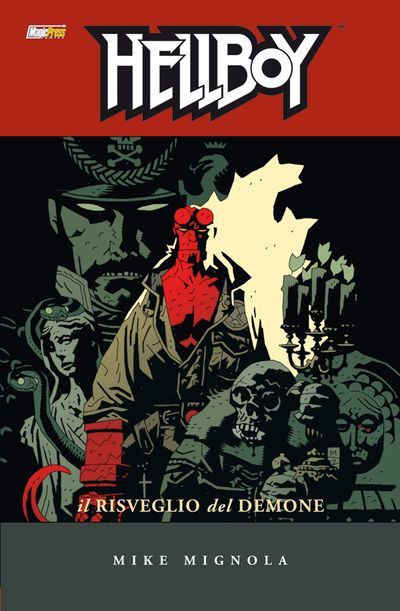



Lascia un commento